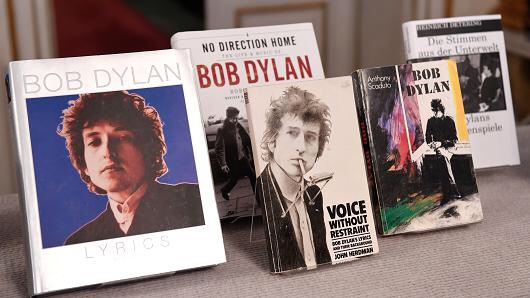RENZO FRANCABANDERA | Ha diritto, un poeta che scrive canzoni e poi le canta imbracciando la chitarra e magari pestando pure con il piede un tamburello, di vincere un premio, il Nobel, che segnala le massime espressioni di un’arte il cui confine sembra piuttosto segnato dalle pagine dei libri che non dagli spartiti?
Se per le altre scienze alle quali viene assegnato Nobel, il confine parrebbe apparire un po’ più netto che per le arti, e già non sono sicuro che questo sia più, l’intervento di qualche scrittore nostrano sull’opportunità o meno di premiare un Dylan, o un De Andrè, per fare qualche nome ulteriore (ma poteva essere Leonhard Cohen o George Brassens), pone il tema di quanto, spesso, gli artisti stessi tengano ai confini del genere con incredibile tenacia, quando invece l’arte è per sua natura contaminazione, tentativo di superare e abbattere gli steccati e le tassonomie.

Se così non fosse stato, sicuramente Joyce non avrebbe scritto l’Ulisse, non avremmo la poesia libera della Beat Generation, non avremmo avuto il dadaismo, il zum sum futurista e le poesie di Ungaretti.
Il premio ad un singolo artista, poi, anima sempre grandissime discussioni, perché santifica, per così dire, una forma codificata e non solo la persona. Un Nobel ad un uomo che utilizza le lettere, il logos, la parola, tipizza anche un genere. Ha avuto, per dire, il Nobel solo Dario Fo o anche il grammelot, la satira sociale condita di neologismi con cui è divenuto celebre?
Onestamente sento che per le generazioni del tempo presente i testi della musica leggera ma pensante, siano stati assai più rilevanti, per i singoli ma anche nella storia dei grandi movimenti di massa della seconda metà del secolo scorso, che non i romanzi e la scrittura tradizionalmente intesa.
Me lo immagino quello del gruppo dei votanti che ha tirato fuori il nome di Dylan, e la faccia degli altri, quelli che erano pronti con i nomi soliti, quelli del: “Beh a questo non possiamo non darglielo, quest’anno!”
E poi mi immagino quel baco che ha iniziato a scavare nei pensieri degli altri giurati, il baco del “Dylan, perché no?”: lo scontro fra tradizione ed innovazione, fra apertura dei confini e loro presidio con il righello misuratore dell’arte de L’attimo fuggente o la bacchetta del professor Perboni sulle nocche del povero Franti.
Esiste sempre un momento di discontinuità. Un momento dal quale non si torna indietro, la perdita della verginità. Un papa che decide dopo duemila anni di telefonare alle persone al numero di casa invece che scrivergli un telegramma in latino. Un Nobel a Dylan.
Ci sono sempre invece i Baricco del mestiere, i bravini della classe, i De Rossi del libro Cuore, a presidiare il diritto del mestiere a vedersi tramandato tale quale, con le forme e i canoni millenari.
Ma la forma attraverso la quale il genere umano esprime le sue emozioni letterarie è liquida per dirla con Baumann, altrimenti ci esprimeremmo graficamente ancora con i geroglifici egiziani ed useremmo ancora l’esametro dattilico con cui sono scritte le opere di Omero.
Fontana, con i suoi tagli era un artista del segno, come Pollock con i suoi dripping, Burri con le sue bruciature e Mimmo Rotella con i suoi decollage, non meno di gente che ha passato la vita a mescolare la trementina ai colori. E sono sicuro che questa affermazione urti i pittori di pennello non meno di quanto il Nobel a Dylan abbia urtato Baricco.

Eppure, sono ugualmente convinto che fino a ieri, e forse anche oggi, Baricco avrebbe difeso e difenderebbe la dominanza del segno sulla tecnica, di Fontana sulla trementina, il teorema di quanto è stato importante il taglio nella tela come forma espressiva, rispetto al lavoro di milioni di ottimi paesaggisti, coevi di Fontana, che continuavano a dipingere golfi di Amalfi, viste delle Dolomiti e vicoli di Roma.
Se così non fosse, nelle forme di arte dal vivo, non avremmo mai visto l’avvento della performing Art, Acconci, Pani, Abramovic, non avremmo il lavoro di Romeo Castellucci e della Societas, che ha rivoluzionato negli anni Ottanta anche il teatro di prosa, ancora fermo, per la gran parte, almeno nelle scenografie, ai fondali di cartone o poco più.
I generi letterari non li fanno poi solo gli scrittori ma anche i lettori, o chi, in qualsiasi modo, li propaga. Sfido uno qualsiasi sostenitore di un qualsiasi scrittore a ricordarne quattro righe di fila, e poi, per esempio, a portare alla mente Blowin in the Wind, o a La guerra di Piero, o Suzanne o Shine on you crazy diamond. Ci deve essere una potenza in questa parola, in questa poesia, che la rende degna di aver occupato e occupare miliardi di neuroni in milioni di cervelli sparsi su questo pianeta.
Con la stessa forza difendo il diritto di queste forme espressive di essere definite letteratura e il diritto che venga definito teatro quello di Florentina Holzinger, giusto per parlare di recenti polemiche italiane su cosa è arte e cosa no; che è lo stesso tema del definire teatro l’opera di Pathosformel e Santasangre, ricordando manifestazioni eclatanti di deformazione del confine dell’arte scenica a cui abbiamo assistito in Italia nell’ultimo decennio.
Sono sicuro che a questo argomento sono vigorosamente contrari, per paradosso, più coloro che hanno passato anni a far sentire il rumore delle ossa sulle tavole del palcoscenico, come predicava Artaud, che non spettatori assetati di novità nel linguaggio dell’arte dal vivo. Gli stessi conservatori che hanno, però, trionfato per il Nobel per la letteratura ad un teatrante, quando fu per Fo, che per giunta usava in scena parole inventate…
Sarei curioso di trovare qualche commento esaltato di allora di Baricco o qualche articolo di quelli come lui per cui l’apertura dei confini va bene solo quando il problema non gli entra in casa, come un migrante; qualche accalorata difesa a sostegno della bandiera olimpica affidata nella cerimonia inaugurale a un “paffutella” tiratrice a segno piuttosto che al solito calciatore.
Io di mio, invece, non vedo l’ora del prossimo Nobel della letteratura a qualche artista che abbia usato la parola senza mai proferirne o scriverne una, ma proiettandone la potenza sull’umanità. Un nuovo Chaplin, magari, un Castellucci, un poeta della parola non detta, o non scritta, insomma.