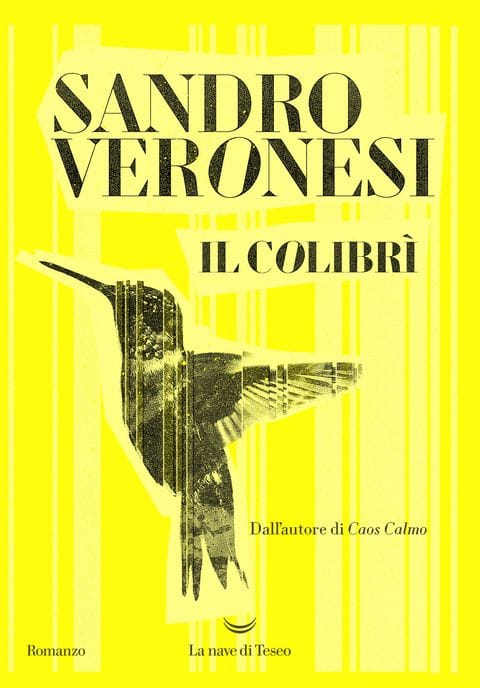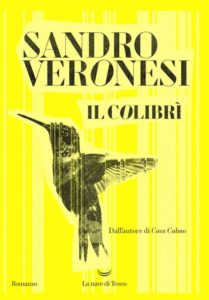I difetti li ho trovati in storie inverosimili, personaggi stereotipati e superficiali, situazioni e caratteri infarciti di luoghi comuni. E infine, in entrambi i casi, la narrazione di ambienti e dimensioni altoborghesi, come se non solo il privilegio di narrare e vincere premi, ma addirittura quello di essere narrati, essere oggetto degno di narrazione, debba essere un’esclusiva dei ricchi. Si espelle la povertà (o anche la “normalità” piccolo borghese) dagli immaginari narrativi. Perché? Per pregiudizi classisti? Perché la gran parte dei narratori non l’hanno mai conosciuta e quindi non saprebbero raccontarla? Perché si ritiene poco interessante? Perché si pensa che chi è impegnato tutti i giorni a “sbarcare il lunario”, o anche a timbrare il cartellino, non viva una vita abbastanza ricca, né pratica né interiore? Perché si tratta di esistenze troppo poco luccicanti e patinate?
I difetti li ho trovati in storie inverosimili, personaggi stereotipati e superficiali, situazioni e caratteri infarciti di luoghi comuni. E infine, in entrambi i casi, la narrazione di ambienti e dimensioni altoborghesi, come se non solo il privilegio di narrare e vincere premi, ma addirittura quello di essere narrati, essere oggetto degno di narrazione, debba essere un’esclusiva dei ricchi. Si espelle la povertà (o anche la “normalità” piccolo borghese) dagli immaginari narrativi. Perché? Per pregiudizi classisti? Perché la gran parte dei narratori non l’hanno mai conosciuta e quindi non saprebbero raccontarla? Perché si ritiene poco interessante? Perché si pensa che chi è impegnato tutti i giorni a “sbarcare il lunario”, o anche a timbrare il cartellino, non viva una vita abbastanza ricca, né pratica né interiore? Perché si tratta di esistenze troppo poco luccicanti e patinate?Spero di no, spero di sbagliarmi, spero non sia così soprattutto oggi in quest’Italia post covid dove la marea dell’indigenza sale inesorabilmente ovunque. Insistere su questa strada significherebbe fuggire dalla realtà e rinunciare a raccontare quel che i media chiamano “paese reale”.
 Ci si rifugia nei tópoi, meglio se eccezionali e patinati, ricchi di “effetti speciali”, perché ci fa paura conoscere la fatica e il dolore e la lentezza dell’introspezione.
Ci si rifugia nei tópoi, meglio se eccezionali e patinati, ricchi di “effetti speciali”, perché ci fa paura conoscere la fatica e il dolore e la lentezza dell’introspezione.dalla pagina Facebook di Fabio Massimo Franceschelli