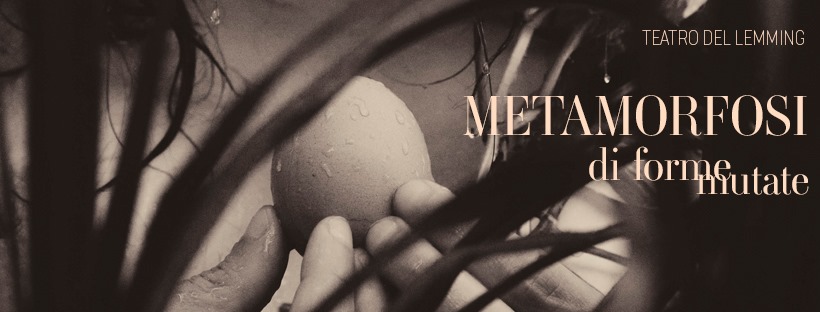RENZO FRANCABANDERA | Siamo il mito che il nostro tempo ci fa vivere. Ora Antigone, ora Edipo, ora Medea.
Il Teatro del Lemming di Rovigo, sotto la direzione artistica di Massimo Munaro, lavora da sempre su questo. Il dialogo fra ere del pensiero umano, alla base di questa ricerca, si riflette anche nel Festival Opera Prima, che si svolgerà anche quest’anno a Rovigo dal 6 al 13 Settembre e che come gli altri anni metterà a confronto i linguaggi dei maestri della scena con le nuove sensibilità emergenti: le letture diverse, le differenti sensibilità nel passaggio delle generazioni, le metamorfosi del linguaggio, pur restando nella caverna platonica del teatro.
E non a caso menzioniamo questo tema della caverna perchè da sempre la dinamica spettacolare scelta dal Teatro del Lemming prevede una immersione nell’abisso dell’identità, nell’oscurità del rituale, cercando tracce e reminiscenze ancora attuali, spravvisute a millenni di storia umana, avendo cura di lasciare fuori dal percorso tracce di connessione tecnologica al mondo.
Ci si sveste dei panni di uomo sociale, si indossa una tunica neutra, uguale per tutti, con cui si azzerano le distanze fra i partecipanti, che diventano una micro comunità di individui spesso ignoti gli uni agli altri ma di fatto compartecipi di un momento collettivo.
A compimento di un lavoro durato tre anni Metamorfosi – nel labirinto della memoria avrebbe dovuto debuttare nel giugno di quest’anno. Dopo diversi Studi preparatori lo spettacolo aveva trovato la sua forma definitiva in un percorso labirintico dedicato a un piccolo gruppo di spettatori, sette a replica. Ma l’esplodere dell’emergenza sanitaria ha reso subito evidente che sarebbe stato impossibile realizzare lo spettacolo per come era stato concepito. Ritornano alla mente gli altri allestimenti, quella dinamica tattile, di sussurri nel buio, di mani che portano, spingono, accarezzano, come nello storico Edipo. Hanno così deciso di rimandare il lavoro alla prossima stagione per preservare la relazione prossemica e sensoriale con lo spettatore che era stata immaginata, sperando davvero che sia possibile realizzarla.
 Come noto, in scena gli attori, seppure senza mascherina, devono mantenere una distanza fra loro di un metro e dallo spettatore di due metri. E gli spettatori, fra loro, almeno di un metro. Di fatto una scure su quella relazione ravvicinata e sensoriale con lo spettatore che da sempre Munaro e il suo gruppo di ricerca pongono al centro del dialogo fra partecipazione e rappresentazione, avendo cura di evitare derive digitali che non appartengono alla storia di questa pratica, per quella che finora è stata. Un atto di coerenza, forte quanto la rinuncia, per ora, al progetto che avrebbe dovuto essere. Cosa è stato dunque Metamorfosi, che sarà possibile, dopo le repliche al Festival dei Tacchi in Sardegna, rivedere proprio a Rovigo, per il Festival Opera prima, il 9 Settembre.
Come noto, in scena gli attori, seppure senza mascherina, devono mantenere una distanza fra loro di un metro e dallo spettatore di due metri. E gli spettatori, fra loro, almeno di un metro. Di fatto una scure su quella relazione ravvicinata e sensoriale con lo spettatore che da sempre Munaro e il suo gruppo di ricerca pongono al centro del dialogo fra partecipazione e rappresentazione, avendo cura di evitare derive digitali che non appartengono alla storia di questa pratica, per quella che finora è stata. Un atto di coerenza, forte quanto la rinuncia, per ora, al progetto che avrebbe dovuto essere. Cosa è stato dunque Metamorfosi, che sarà possibile, dopo le repliche al Festival dei Tacchi in Sardegna, rivedere proprio a Rovigo, per il Festival Opera prima, il 9 Settembre.
Di forme mutate è la risposta alle limitazioni, un ripensamento della creazione originaria, una sorta di espunzione della parte possibile del rito, alla ricerca di un senso specifico dell’atto creativo, consapevoli che deve essere pensato, forse, come parte di un tutto inesprimibile. Liberamente ispirata alle Metamorfosi di Ovidio, la creazione propone come si diceva un’immersione intima e personale nello spazio del rito, cui si ha accesso in gruppi di soli cinque spettatori a replica che entrano in uno spazio oscuro, illuminato da fioche candele e in cui una serie di interpreti, a metà fra il ruolo di officianti e quello di performer, dialogano a distanza – e diversamente non potrebbe essere – con gli spettatori seduti molto distanziati fra loro attorno a una sorta di area magica. Vengono richiamati i gesti, i suoni, gli odori dell’ancestralità concettuale della metamorfosi, dall’acqua al fuoco alla terra, elementi parmenidei, fino allo specchio, spesso presente nelle azioni del Lemming.
 L’obiettivo forse, consapevoli dell’intento circoscritto e parziale dell’esito, è quello di lasciare, pur distanza, la persistenza di una sensazione più che di un compiuto ragionamento d’arte. È come entrare in un rito a suo modo alchemico, in cui non tutto è intuitivo e comprensibile, ma in cui si avvertono gli elementi costitutivi della sensazione, il piccolo disagio, la sorpresa, il sotteso erotico e quasi psicanalitico, mai esplicito o didascalico ma avvertibile dove la sensibilità soggettiva lo permette. Nessuna parola se non quella che ci arriva attraverso altoparlanti. Frasi ripetute. Litanie scenico-liturgiche.
L’obiettivo forse, consapevoli dell’intento circoscritto e parziale dell’esito, è quello di lasciare, pur distanza, la persistenza di una sensazione più che di un compiuto ragionamento d’arte. È come entrare in un rito a suo modo alchemico, in cui non tutto è intuitivo e comprensibile, ma in cui si avvertono gli elementi costitutivi della sensazione, il piccolo disagio, la sorpresa, il sotteso erotico e quasi psicanalitico, mai esplicito o didascalico ma avvertibile dove la sensibilità soggettiva lo permette. Nessuna parola se non quella che ci arriva attraverso altoparlanti. Frasi ripetute. Litanie scenico-liturgiche.
E d’altronde di una cosa occorre dare atto a questo gruppo di ricerca ovvero della unicità nel panorama italiano di una pratica così specifica e di confine, che per i praticanti del teatro sensoriale ha chiare forme espressive e codici, ma che vengono sempre pensate in modo molto archetipico, con una profondità coraggiosa, di cui gli attori si fanno interpreti. Perfettibile il corredo sonoro, a tratti leggermente in distorsione, ma al netto di questo piccolo particolare probabilmente occasionale durante la replica cui ho assistito, il resto lascia l’idea non di uno spettacolo, e questo è un bene. Non di un atto compiuto, e questo è onesto rispetto all’intento.
È una testimonianza di profondità, un tentativo di chiedersi: quanto cambia il rito teatrale se la sua forma è mutata, costretta, costipata in un taglio lacerante? È una metamorfosi dolorosa quella cui si assiste, come a chiedere se il momento eucaristico da solo può condensare l’intero rito liturgico per un cristiano, o se, pur considerata la dedizione sacrale, quell’atto da solo non può bastare.
Il rito sociale, di fatto fondamento rappresentativo del teatro, ha bisogno di alcuni ingredienti fondanti. Lemming crudamente cerca non di evitare la mancanza, ma di indagarla, lasciandoci il chiaro senso dell’incompiuto. Nulla può sostituire.
Senza alcune dinamiche, il rituale umano – e il teatro è questo – perde elementi di significazione. Di forme mutate ci mette davanti a questa considerazione, con il piccolo specchio tondo con cui veniamo chiamati a osservarci per capire cosa ci aspettiamo, cosa vediamo, di noi stessi, del mondo. E cosa ha cancellato questo momento della storia collettiva. Resta un senso nel cibarsi comunque del corpo cristologico dell’atto teatrale, anche quando la liturgia è monca?
Questa, secondo me, la domanda profonda di questa creazione.