 MATTEO BRIGHENTI | Fare, dire basta, lasciare, telefonate, testamento. Il 25 aprile scorso, giorno della Liberazione, Iacopo Braca si è liberato dei riflettori. “Da un anno sono fuori dalle nuove produzioni di Teatro Sotterraneo. Ho continuato a fare le repliche dei vecchi spettacoli, ho portato avanti progetti artistici miei, ma a ottobre dirò addio al teatro. Non andrò più in scena, con nessuno.”
MATTEO BRIGHENTI | Fare, dire basta, lasciare, telefonate, testamento. Il 25 aprile scorso, giorno della Liberazione, Iacopo Braca si è liberato dei riflettori. “Da un anno sono fuori dalle nuove produzioni di Teatro Sotterraneo. Ho continuato a fare le repliche dei vecchi spettacoli, ho portato avanti progetti artistici miei, ma a ottobre dirò addio al teatro. Non andrò più in scena, con nessuno.”
Il regista, attore e performer fiorentino adesso vuole essere e fare altro. Morire in volo. 17 anni di teatro, alla Residenza per anziani “Il Giglio” di Firenze, è il primo passo: un “harakiri” condiviso per guardarsi dentro, elaborare i perché di una scelta, comunque definitiva, attorno a un tavolo con estranei e amici, poi maestri, colleghi, amori di una carriera sulla scena “presenti” al cellulare, via Facebook e Skype. Tutti o almeno quelli raggiungibili in 5 ore, dalle 11 alle 16 (poi diventate 18). Da Roberto Corradino a Laura Dondoli, da Giancarlo Cauteruccio a Benno Steinegger a Luca Camilletti.
“La mia non è una scelta di tipo economico, è di vita. Ho nuovi interessi, nuove visioni. Rimanere dov’ero mi è sembrato un limite, anche perché, secondo il mio punto di vista, l’ho già vissuto alla grande.”
Braca parla con serenità spiazzante, ha 34 anni, ma ha già raggiunto ciò che voleva: insieme al collettivo Teatro Sotterraneo www.teatrosotterraneo.it (fondato a Firenze nel 2004 con Sara Bonaventura, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, ai quali si è unito in seguito Daniele Villa) ha vinto, tra gli altri, l’Ubu Speciale, ha diretto un’opera lirica, Il signor Bruschino di Gioachino Rossini per il Rossini Opera Festival, ha avuto insomma successo, di critica e di pubblico.
“A me è sempre interessato il pubblico. Prima di entrare in scena contavo le persone per capire a quanti arrivava il nostro messaggio. Il teatro è un ottimo mezzo per comunicare. Mi dispiace, però, per i contesti in cui l’abbiamo fatto, sarebbe stato bello andare in spazi con bacini di utenza più ampi.”
Forse è per questa sua “ossessione” di comunicare al maggior numero di persone possibile che anche la scelta di abbandonare il teatro è diventata teatro. L’occasione si è presentata con il progetto Esperimento deserto (http://esperimentodeserto.wordpress.com), liberamente tratto da Il deserto dei Tartari di Buzzati, un percorso di residenze in spazi teatrali e non che affronta il tema della passione, ideato, realizzato e condotto dal compagno d’avventure Alessio Martinoli (Braca l’ha diretto in Fight_tentativi di sopravvivenza dell’essere umano e in Fallo! Un omaggio a Lenny Bruce). Martinoli lo ha invitato a parlare del suo romanzo preferito, lui ha scelto Lo straniero di Camus e ha proposto di usare la giornata per riprendere in mano le tessere del puzzle della sua biografia teatrale e scrivere il libro di cui parlano da mesi. Hanno chiamato quindi il drammaturgo Lorenzo Garozzo (Premio Hystrio scritture di scena 2013 per JTB), con cui hanno collaborato per una delle declinazioni di Fight: sarà lui a sostenere, con Martinoli, lo sguardo e le domande di Braca, lui metterà ordine e darà forma a questa confessione-spettacolo. Così è nato Morire in volo. 17 anni di teatro.
Una telefonata dietro l’altra, Braca scorre i “grani” della sua formazione, gli inizi con Stefano Massini, l’incontro con Claudio Ascoli e la scoperta del teatro fisico oltre quello di parola, la prestigiosa collaborazione con il Living Theatre, finché un giornalista non gli dice: “Che fai? Questa roba è vecchia di 30 anni!” È l’estate del 2004. Deve decidere: partire con loro per New York o dedicarsi seriamente a Teatro Sotterraneo, che ha già fondato per “condividere un percorso con degli amici”. Braca sceglie di dare una possibilità al futuro. “Dobbiamo tutto alla nostra freschezza, all’immediatezza, al lavoro sul ritmo, sulla frammentazione totale come in Post-it e sull’opportunità di far entrare lo spettatore in maniera semplice, anche con una risata. Questi sketch, propri del teatro comico, ma virati sull’ironia, con la possibilità quindi di essere anche seri, erano una novità.”
Poi, finisce la spinta, il razzo perde propulsione, i giorni chiusi in sala-prove diventano un’astrazione dal mondo insopportabile, il sistema si mostra in tutta la sua falsità. Le vie d’uscita per Iacopo Braca sono state il suo matrimonio e la pedagogia: insegnare a dire una cosa e dopo farla, portare avanti obiettivi artistici che abbiano delle ricadute sulla propria vita. “Voglio utilizzare la mia esperienza nell’ambito della formazione. A fine giugno metterò online la mia nuova attività. A ottobre saluterò per sempre il palcoscenico.”
Braca, dunque, dice addio al mestiere del teatrante, non alla disciplina, alla quotidianità, non alla convinzione di stare facendo qualcosa per gli altri, con gli altri, attraverso di sé. Il suo allora non è un abbandono: è la ricerca di una nuova forma di fare teatro. Libera, vera, concreta. Altrimenti, come dice Kostja ne Il gabbiano di Čhecov, meglio niente.


 FRANCESCA GIULIANI | Terminata la quarta edizione delle giornate di puericultura teatrale a Cesena, Chiara Guidi ci racconta “Puerilia”, un festival che nasceva con l’intento di dilatare la visone che sta attorno alla concezion del teatro dell’infanzia.
FRANCESCA GIULIANI | Terminata la quarta edizione delle giornate di puericultura teatrale a Cesena, Chiara Guidi ci racconta “Puerilia”, un festival che nasceva con l’intento di dilatare la visone che sta attorno alla concezion del teatro dell’infanzia. 
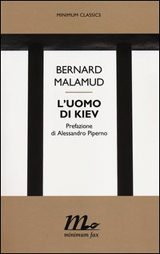


 NICOLA ARRIGONI Buchettino della Societas Raffaello Sanzio non è solo uno spettacolo, è l’inizio della più accreditata compagnia di ricerca del teatro italiano, è un classico in cui il teatro si fa esperienza. Per questo motivo – forse – vive di una sua longevità che non è concessa facilmente al sistema teatrale e produttivo italiano. Buchettino è l’immagine metonimica della Societas Raffaello Sanzio, è la parte e il tutto di un estetica in nuce che chiede allo spettatore di essere autore, di essere parte dello spettacolo, qui realmente per l’annullamento delle distanza fra palco e platea, negli spettacoli proposti in questi decenni dalla Societas intellettualmente. L’allestimento – ideato da Romeo Castellucci e Chiara Guidi e Claudia Castellucci – è complesso e affascinante. Romeo Castellucci si è inventato una baracca con cinquanta lettini in cui altrettanti spettatori sono chiamati a distendersi. Lo spettacolo è pensato per bambini dagli otto anni ai 90: come dire vuole recuperare un antico rito: quello del raccontare le fiabe. Ed in fondo è quanto accade. Invitati dall’attrice/narratrice Silvia Pasello per una sera si è bambini prima della nanna, infanti che attendono il racconto notturno. La storia narrata non è delle più tranquillizzanti, si tratta di Buchettino di Charles Perrault, altrimenti noto con Pollicino. La vicenda di Buchettino e dei suoi fratelli, prima abbandonati dai genitori per troppa miseria ed egoismo, poi in balia dell’orco del bosco è nota, ma la curiosità e il coinvolgimento dello spettacolo della Societas Raffaello Sanzio sta nel tempo e spazio presente del teatro. Distesi sui cinquanta lettini si è ‘bambini’, il racconto della fiaba diviene realtà, incubo sonoro. I passi, l’aprire e chiudere le porte, il muoversi dei genitori di Buchettino sono raccontati da Silvia Pasello, ma diventano presenze ‘reali’ nel qui ed ora della scena grazie all’ambientazione sonora realizzata da Romeo Castellucci. La distanza del narrare si annulla, e il racconto diventa esperienza esperita direttamente. Si passa lentamente dall’assistere ad una storia all’essere nella favola. Pian piano la narratrice diviene personaggio, assume la voce dell’orco, si muta da raccontatrice a personaggio mimico/sonoro. Così gli spettatori/bambini da piccoli in attesa di addormentarsi, diventano Buchettino e i suoi fratellini. E’ questo accorciarsi delle distanze, sono le suggestioni sonore che circondano e invadono quella stanza/baracca di legno immersa in un’oscurità rotta solo da una lampadina a fare di Buchettino non solo uno spettacolo, un classico che è in tour da almeno quindici, vent’anni, ma a farne una bella esperienza e al tempo stesso una riflessione sulla forza della narrazione, sulla capacità del teatro di evocare e inventare la realtà, accorciando le distanze col mondo della fantasia e delle favole. E scusate se è poco.
NICOLA ARRIGONI Buchettino della Societas Raffaello Sanzio non è solo uno spettacolo, è l’inizio della più accreditata compagnia di ricerca del teatro italiano, è un classico in cui il teatro si fa esperienza. Per questo motivo – forse – vive di una sua longevità che non è concessa facilmente al sistema teatrale e produttivo italiano. Buchettino è l’immagine metonimica della Societas Raffaello Sanzio, è la parte e il tutto di un estetica in nuce che chiede allo spettatore di essere autore, di essere parte dello spettacolo, qui realmente per l’annullamento delle distanza fra palco e platea, negli spettacoli proposti in questi decenni dalla Societas intellettualmente. L’allestimento – ideato da Romeo Castellucci e Chiara Guidi e Claudia Castellucci – è complesso e affascinante. Romeo Castellucci si è inventato una baracca con cinquanta lettini in cui altrettanti spettatori sono chiamati a distendersi. Lo spettacolo è pensato per bambini dagli otto anni ai 90: come dire vuole recuperare un antico rito: quello del raccontare le fiabe. Ed in fondo è quanto accade. Invitati dall’attrice/narratrice Silvia Pasello per una sera si è bambini prima della nanna, infanti che attendono il racconto notturno. La storia narrata non è delle più tranquillizzanti, si tratta di Buchettino di Charles Perrault, altrimenti noto con Pollicino. La vicenda di Buchettino e dei suoi fratelli, prima abbandonati dai genitori per troppa miseria ed egoismo, poi in balia dell’orco del bosco è nota, ma la curiosità e il coinvolgimento dello spettacolo della Societas Raffaello Sanzio sta nel tempo e spazio presente del teatro. Distesi sui cinquanta lettini si è ‘bambini’, il racconto della fiaba diviene realtà, incubo sonoro. I passi, l’aprire e chiudere le porte, il muoversi dei genitori di Buchettino sono raccontati da Silvia Pasello, ma diventano presenze ‘reali’ nel qui ed ora della scena grazie all’ambientazione sonora realizzata da Romeo Castellucci. La distanza del narrare si annulla, e il racconto diventa esperienza esperita direttamente. Si passa lentamente dall’assistere ad una storia all’essere nella favola. Pian piano la narratrice diviene personaggio, assume la voce dell’orco, si muta da raccontatrice a personaggio mimico/sonoro. Così gli spettatori/bambini da piccoli in attesa di addormentarsi, diventano Buchettino e i suoi fratellini. E’ questo accorciarsi delle distanze, sono le suggestioni sonore che circondano e invadono quella stanza/baracca di legno immersa in un’oscurità rotta solo da una lampadina a fare di Buchettino non solo uno spettacolo, un classico che è in tour da almeno quindici, vent’anni, ma a farne una bella esperienza e al tempo stesso una riflessione sulla forza della narrazione, sulla capacità del teatro di evocare e inventare la realtà, accorciando le distanze col mondo della fantasia e delle favole. E scusate se è poco.
 FRANCESCA GIULIANI | L’atto del vedere non è mai ricettivo: è un processo di selezione di proiezioni di significati, di emozioni, che fanno si che l’atto visivo non sia per nulla un atto naturale, ma un atto di pensiero, afferma Stefani Chiodi, critico d’arte con il quale si è chiuso il ciclo di dialoghi tra spettatori e pensatori (Massimo Recalcati, Andrea Canevaro, Maria Rosa Sossai e Louise Ejgod Hansen) sull’arte nel nostro tempo, tenutosi al Teatro Comandini di Cesena durante “Puerilia”. Nel quarto anno di attività, Chiara Guidi/Socìetas Raffaello Sanzio, ideatrice e direttrice delle giornate di puericultura teatrale, si concentra sul suo Metodo Errante, un linguaggio d’arte che non cerca la scrittura di una regola ma la domanda che muove il pensiero. Il Metodo si sviluppa in tre movimenti: verso gli insegnanti, con dei seminari (Il potere anacronistico dell’anima, 2014, Il potere analogico della bellezza, 2013, e La potenza analfabetica della fantasia incentrati sulla creazione degli spettacoli, 2011), verso gli attori, con due laboratori (per 15 partecipanti) incentrati sulla creazione degli spettacoli, e per il bambino stesso.
FRANCESCA GIULIANI | L’atto del vedere non è mai ricettivo: è un processo di selezione di proiezioni di significati, di emozioni, che fanno si che l’atto visivo non sia per nulla un atto naturale, ma un atto di pensiero, afferma Stefani Chiodi, critico d’arte con il quale si è chiuso il ciclo di dialoghi tra spettatori e pensatori (Massimo Recalcati, Andrea Canevaro, Maria Rosa Sossai e Louise Ejgod Hansen) sull’arte nel nostro tempo, tenutosi al Teatro Comandini di Cesena durante “Puerilia”. Nel quarto anno di attività, Chiara Guidi/Socìetas Raffaello Sanzio, ideatrice e direttrice delle giornate di puericultura teatrale, si concentra sul suo Metodo Errante, un linguaggio d’arte che non cerca la scrittura di una regola ma la domanda che muove il pensiero. Il Metodo si sviluppa in tre movimenti: verso gli insegnanti, con dei seminari (Il potere anacronistico dell’anima, 2014, Il potere analogico della bellezza, 2013, e La potenza analfabetica della fantasia incentrati sulla creazione degli spettacoli, 2011), verso gli attori, con due laboratori (per 15 partecipanti) incentrati sulla creazione degli spettacoli, e per il bambino stesso.