 RENZO FRANCABANDERA | Illuminata di rosso fuoco. Su una scena complessa e particolarmente strutturata si apre il sipario del Teatro Carcano per ospitare le repliche de L’Avaro di Moliere di e con Arturo Cirillo.
RENZO FRANCABANDERA | Illuminata di rosso fuoco. Su una scena complessa e particolarmente strutturata si apre il sipario del Teatro Carcano per ospitare le repliche de L’Avaro di Moliere di e con Arturo Cirillo.
Il lavoro nella sua struttura contempla una serie di riflessioni metodologico-filosofiche sul testo su cui vale la pena soffermarsi. Innanzitutto il tema della centralità del personaggio de L’Avaro rispetto alle altre figure, ancillari e quasi vuote di significato, indistinta massa di “servi di scena”. La seconda è sul concetto di inganno morale della ricchezza ma anche di tutto quello che le ruota intorno e di come il denaro falsi la percezione delle reali grandezze delle cose.
Sotto questo aspetto, l’elemento scenografico messo a punto da Dario Gessati, costruito da alcune sezioni di cubo in prospettiva centrale, spoglie e trasandate, appare un felice richiamo al gioco architettonico sostanzialmente coevo all’opera di Moliere, creato alla metà del 1600 da Borromini per Bernardino Spada, a Palazzo Spada a Roma.
Anche lì una finta prospettiva crea l’illusione che la galleria sia lunga oltre metri, mentre in realtà è lunga 8,82 metri, un’illusione dovuta all’unicità del punto di fuga, con il soffitto che scende e il pavimento che sale. Probabile lo stesso espediente ricorra in questa scena visto che l’effetto è sostanzialmente simile. L’operazione di modernità scenografica, e da molti punti di vista musicale (versioni distorte e acide di pezzi classici), pare di sentire in alcuni frammenti) non corrisponde a un altrettanto radicale lavoro sul testo, per il quale si preferisce la tradizione.
Cirillo a parte, in abito nero e parrucca, la compagine attorale, composta da Michelangelo Dalisi (Cleante), Monica Piseddu (Elisa), Luciano Saltarelli (Valerio), Antonella Romano (Mariana) , Salvatore Caruso (Anselmo – Saetta – Fildavena) , Sabrina Scuccimarra (Frosina), Giuseppina Cervizzi (Mastro Simone – Baccalà – Commissario), Rosario Giglio (Mastro Giacomo), indossa abiti slavati dalla cintola in giù (con quell’effetto varichina delle magliettine anni 90), che restituiscono un’atmosfera goticheggiante post punk. Quanto al recitato, preferiamo l’interpretazione misurata e non incline alla nota comica anche solo accennata, come ad altri purtroppo qui e lì capita, di Dalisi e della Piseddu. Proprio la sottrazione del codice comico dal testo infatti, potrebbe essere la maggior forza di questa lettura, che però non viene portata fino in fondo, cedendo di quanto in quanto ad una dimensione di fruibilità più allargata e facile, quindi meno radicale.
E questa questione della medietà della posizione registica fra possibilità interessanti di un allestimento audace e riproposizione capocomicale di un testo classico resta in piedi per tutta la recita. E’ indubbio che la scelta sia comunque quella di un Arpagone che mira ai grandi personaggi drammatici shakespeariani, qualcosa che ricorda perfino le interpretazioni cinematografiche di Shylock o Riccardo III di Al Pacino. L’operazione si ferma in una terra di mezzo, fra tradizione e sperimentazione, fra desiderio di rimanere vicini ad un pubblico abituato al classico “classico” e la possibilità di introdurre codici nuovi.
Cirillo restituisce un’interpretazione da capocomico d’un tempo, caricando il grosso dello spettacolo sulle spalle del suo Arpagone, allontanandosi concettualmente da letture, che pure non sono mancate, che aggiungevano pepe, ad esempio, alla figura di Frosina, presunta serva padrona, orditrice di chissà quali sofisticate trame. Arpagone qui è si sconfitto, ma in fondo teatralmente è chiamato a trionfare sul resto dell’umanità di cui si fatica a leggere uno spessore vero. Ma questa è d’altronde anche la grandezza del testo di Molière.
L’istantanea degli altri personaggi in posa, in bilico dentro una cornice che li spinge fuori dalla foto, la scelta di richiamare il codice della commedia dell’arte e dei pupi, e altre idee felici di leggere il testo oltre il testo, si fermano in un territorio dai confini indefiniti e troppo poco marcati. Sicuramente si poteva osare oltre, magari accontentando qualcuno in meno, ma spingendosi verso un ambito probabilmente più gratificante dal punto di vista della sfida. Nonostante qualche interessante incursione in territori di sperimentazione, il cui peso rimane tuttavia non tale da spostare l’equilibrio generale, il fulcro concettuale dell’esito scenico resta centrato sulla parola, mentre in questa messa in scena, a nostro avviso, le maggiori soddisfazioni arrivano proprio nei momenti in cui si passa dal codice verbale a quello non verbale.


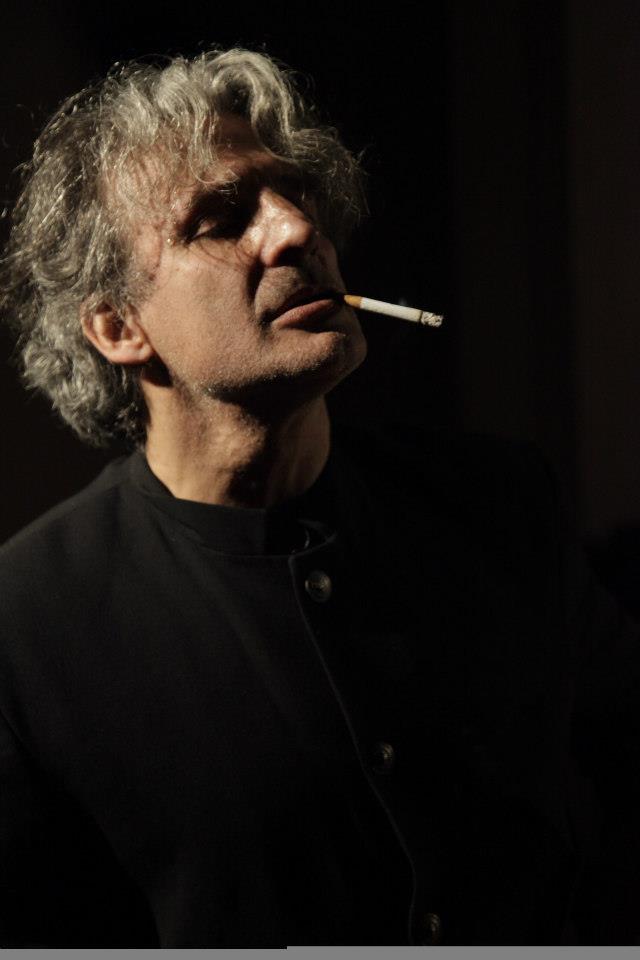 ELENA SCOLARI | Continuiamo il dossier su Teatro e anni ’70 in Italia aperto con l’intervista al giornalista Piero Colaprico. Abbiamo incontrato i registi César Brie e Aldo Cassano (Animanera), due generazioni anagrafiche a confronto. Abbiamo condiviso con loro alcune riflessioni sul rapporto tra cronaca e resa teatrale di fatti storici.
ELENA SCOLARI | Continuiamo il dossier su Teatro e anni ’70 in Italia aperto con l’intervista al giornalista Piero Colaprico. Abbiamo incontrato i registi César Brie e Aldo Cassano (Animanera), due generazioni anagrafiche a confronto. Abbiamo condiviso con loro alcune riflessioni sul rapporto tra cronaca e resa teatrale di fatti storici.
 RENZO FRANCABANDERA | La triste considerazione del potere di coercizione e di demolizione sul sogno individuale e creativo di gioventù che può avere il consesso sociale ha in questi giorni a Milano non solo la declinazione imponente dell’allestimento di Marthaler al Piccolo Teatro, ma anche la coraggiosa, economica e avvincente lettura che Lino Musella e Paolo Mazzarelli hanno costruito con La società, in scena al Filodrammatici fino a domenica 13, di cui firmano drammaturgia e regia.
RENZO FRANCABANDERA | La triste considerazione del potere di coercizione e di demolizione sul sogno individuale e creativo di gioventù che può avere il consesso sociale ha in questi giorni a Milano non solo la declinazione imponente dell’allestimento di Marthaler al Piccolo Teatro, ma anche la coraggiosa, economica e avvincente lettura che Lino Musella e Paolo Mazzarelli hanno costruito con La società, in scena al Filodrammatici fino a domenica 13, di cui firmano drammaturgia e regia.
 NICOLA ARRIGONI | Nymphomaniac incarna una tendenza, porta a sintesi, con la straordinaria e spaziante visionarietà di Lars von Trier, la disperazione del nostro tempo e il bisogno di sincerità. Accade nel film che annunciato come scandaloso, erotico, pornografico – versione tagliata nelle sale italiane con buon placet del regista – in realtà è film etico e puritano, casto nel suo approccio alla fisicità come veicolo per arrivare all’anima. Nel film di Lars Von Trier si intuisce un bisogno di verità e pensiero, ma al tempo stesso la disperazione del corpo come unico orizzonte possibile, come campo di gioco coercitivo e costrittivo in cui – volenti o nolenti – si gioca tutto il nostro stare al mondo.
NICOLA ARRIGONI | Nymphomaniac incarna una tendenza, porta a sintesi, con la straordinaria e spaziante visionarietà di Lars von Trier, la disperazione del nostro tempo e il bisogno di sincerità. Accade nel film che annunciato come scandaloso, erotico, pornografico – versione tagliata nelle sale italiane con buon placet del regista – in realtà è film etico e puritano, casto nel suo approccio alla fisicità come veicolo per arrivare all’anima. Nel film di Lars Von Trier si intuisce un bisogno di verità e pensiero, ma al tempo stesso la disperazione del corpo come unico orizzonte possibile, come campo di gioco coercitivo e costrittivo in cui – volenti o nolenti – si gioca tutto il nostro stare al mondo. RENZO FRANCABANDERA | Alessandra Moretti del Pd è ospite del programma “L’arena” condotto da Massimo Giletti. I due si danno del “lei”, ma pochi mesi prima sono stati anche al mare insieme. A testimoniarlo ci sono fotografie già pubblicate che li ritraggono in costume, al mare, fuori dal mare, in riva al mare, al sole vicino al mare, vicini al mare e sotto al sole e blàblàblà.
RENZO FRANCABANDERA | Alessandra Moretti del Pd è ospite del programma “L’arena” condotto da Massimo Giletti. I due si danno del “lei”, ma pochi mesi prima sono stati anche al mare insieme. A testimoniarlo ci sono fotografie già pubblicate che li ritraggono in costume, al mare, fuori dal mare, in riva al mare, al sole vicino al mare, vicini al mare e sotto al sole e blàblàblà.
 COSIMA PAGANINI | Lo abbiamo visto tutti o quasi.
COSIMA PAGANINI | Lo abbiamo visto tutti o quasi. ALESSANDRO MASTANDREA | “Siamo in guerra”, sono mesi che Beppe Grillo lo ripete, ed Enrico Mentana deve averci creduto, se, visti i tempi incerti, ha deciso di fare di necessità virtù, trasformando lo studio del proprio TG nel campo base da cui dirigere l’offensiva mediatica de La7.
ALESSANDRO MASTANDREA | “Siamo in guerra”, sono mesi che Beppe Grillo lo ripete, ed Enrico Mentana deve averci creduto, se, visti i tempi incerti, ha deciso di fare di necessità virtù, trasformando lo studio del proprio TG nel campo base da cui dirigere l’offensiva mediatica de La7. Non vi è infatti diretta dal Parlamento che non la veda presente e vigile, pronta a raccogliere testimonianze e interviste dagli attori protagonisti di questa perenne guerra di trincea. Nessun giorno di riposo per lei, che ha sacrificato la propria vita privata per la maggior gloria del suo TG. Complice, suo malgrado, della lenta metamorfosi dell’emittente per la quale lavora in una rete all-news, alla Sardoni non rimane che pregare perché scoppi improvvisa la pace, o, quantomeno, un armistizio che la salvi dalle continue fibrillazioni della politica. E’ forse chiedere troppo una serata da passare serenamente a casa sul divano, senza il terrore del telefono che squilla, con all’altro capo della linea il mefistofelico direttore?
Non vi è infatti diretta dal Parlamento che non la veda presente e vigile, pronta a raccogliere testimonianze e interviste dagli attori protagonisti di questa perenne guerra di trincea. Nessun giorno di riposo per lei, che ha sacrificato la propria vita privata per la maggior gloria del suo TG. Complice, suo malgrado, della lenta metamorfosi dell’emittente per la quale lavora in una rete all-news, alla Sardoni non rimane che pregare perché scoppi improvvisa la pace, o, quantomeno, un armistizio che la salvi dalle continue fibrillazioni della politica. E’ forse chiedere troppo una serata da passare serenamente a casa sul divano, senza il terrore del telefono che squilla, con all’altro capo della linea il mefistofelico direttore? MATTEO BRIGHENTI | La guerra è un coro di donne strappate all’incendio del pianto. Giancarlo Cauteruccio cerca di arginare il rigurgito delle lacrime tirando su con il naso. Troia cade e gli cade in gola, i crolli sono continui, battenti, vivi negli accenti e schianti delle batterie, dei vibrafoni e degli xilofoni del gruppo “Flampercussion” della Scuola Media “Enrico Fermi” di Scandicci, diretto dal M° Luca Marino. La sconfitta totale della città inespugnabile non ha madri, figlie né sorelle, soltanto musica e parole sfinite di singhiozzi.
MATTEO BRIGHENTI | La guerra è un coro di donne strappate all’incendio del pianto. Giancarlo Cauteruccio cerca di arginare il rigurgito delle lacrime tirando su con il naso. Troia cade e gli cade in gola, i crolli sono continui, battenti, vivi negli accenti e schianti delle batterie, dei vibrafoni e degli xilofoni del gruppo “Flampercussion” della Scuola Media “Enrico Fermi” di Scandicci, diretto dal M° Luca Marino. La sconfitta totale della città inespugnabile non ha madri, figlie né sorelle, soltanto musica e parole sfinite di singhiozzi.