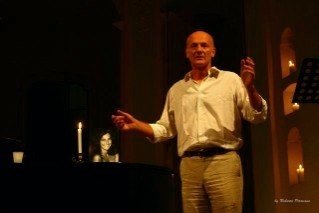GIULIA MURONI| È la storia di una ventiduenne trovata morta dopo una serata in discoteca.È la storia dell’uso strumentale che i dispositivi mediatici (giornalisti), giuridici (magistrati) e repressivi (polizia) fanno di un corpo femminile e del suo tragico esito colposo. “Natura morta in un fosso”, dal testo di Fausto Paravidino, messo in scena dalla compagnia Nessun Vizio Minore, visto allo spazio Il Cubo a Torino presso le Officine Corsare, apre dei varchi di senso su molteplici direttive: l’uso giornalistico della cronaca nera che, vertendo prima sul pruriginoso e poi sul determinismo sociale (sono i soggetti “a rischio” quelli a cui succedono le cose brutte) denuclearizza la violenza di genere; l’apparato giudiziario preoccupato soltanto della percezione che dà di sé, la famiglia borghese mina inesplosa di conflitti e dinamiche malate. Sebbene la narrazione abbia un andamento ritmato e l’ironia faccia da contrappunto, la trama è tragica e non soltanto per l’assassinio violento di una donna, elemento centrale della storia, ma anche per il sottotesto di solitudine a cui sembra destinata l’umanità, intrisa e intristita nei propri piccoli affarucci e interessi. Un’umanità senza scampo quella del testo di Paravidino, laddove nemmeno la vittima sembra essere esente dall’antropologia impietosa che aleggia su tutti loro. Come ne “Il capitale umano” di Virzì o “La giusta distanza” di Mazzacurati, l’atmosfera della provincia nel Nord Italia appare opprimente, le piccole comunità borghesi, dietro facciate rassicuranti e ordinate, celano esistenze miserabili, anestetizzate dal fatturato, dalla fabbrichetta e dalla sembianze consone.
GIULIA MURONI| È la storia di una ventiduenne trovata morta dopo una serata in discoteca.È la storia dell’uso strumentale che i dispositivi mediatici (giornalisti), giuridici (magistrati) e repressivi (polizia) fanno di un corpo femminile e del suo tragico esito colposo. “Natura morta in un fosso”, dal testo di Fausto Paravidino, messo in scena dalla compagnia Nessun Vizio Minore, visto allo spazio Il Cubo a Torino presso le Officine Corsare, apre dei varchi di senso su molteplici direttive: l’uso giornalistico della cronaca nera che, vertendo prima sul pruriginoso e poi sul determinismo sociale (sono i soggetti “a rischio” quelli a cui succedono le cose brutte) denuclearizza la violenza di genere; l’apparato giudiziario preoccupato soltanto della percezione che dà di sé, la famiglia borghese mina inesplosa di conflitti e dinamiche malate. Sebbene la narrazione abbia un andamento ritmato e l’ironia faccia da contrappunto, la trama è tragica e non soltanto per l’assassinio violento di una donna, elemento centrale della storia, ma anche per il sottotesto di solitudine a cui sembra destinata l’umanità, intrisa e intristita nei propri piccoli affarucci e interessi. Un’umanità senza scampo quella del testo di Paravidino, laddove nemmeno la vittima sembra essere esente dall’antropologia impietosa che aleggia su tutti loro. Come ne “Il capitale umano” di Virzì o “La giusta distanza” di Mazzacurati, l’atmosfera della provincia nel Nord Italia appare opprimente, le piccole comunità borghesi, dietro facciate rassicuranti e ordinate, celano esistenze miserabili, anestetizzate dal fatturato, dalla fabbrichetta e dalla sembianze consone.  Pregevole il lavoro della compagnia Nessun Vizio Minore, una trama noir su una resa scenica efficace e briosa. Non un monologo, come fece Serena Sinigaglia nella prima rappresentazione del 2001, bensì un racconto corale in cui i sei personaggi ricostruiscono tassello per tassello l’intreccio che ha condotto alla morte di Elisa Orlando, mostrando da angolazioni ogni volta differenti le molteplici facce del perbenismo, dell’ipocrisia borghese e della bassezza. Un quadrato di nastro bianco fa da perimetro alla scena, sul proscenio lo stesso nastro disegna la sagoma della vittima. Molto semplici le luci: i puntamenti caldi nei momenti di monologo, lo sfumato blu nei cambi di scena e le lampade al neon, accese in sincrono e spente a canone fendono l’oscurità come per dare rilievo a certi accadimenti.
Pregevole il lavoro della compagnia Nessun Vizio Minore, una trama noir su una resa scenica efficace e briosa. Non un monologo, come fece Serena Sinigaglia nella prima rappresentazione del 2001, bensì un racconto corale in cui i sei personaggi ricostruiscono tassello per tassello l’intreccio che ha condotto alla morte di Elisa Orlando, mostrando da angolazioni ogni volta differenti le molteplici facce del perbenismo, dell’ipocrisia borghese e della bassezza. Un quadrato di nastro bianco fa da perimetro alla scena, sul proscenio lo stesso nastro disegna la sagoma della vittima. Molto semplici le luci: i puntamenti caldi nei momenti di monologo, lo sfumato blu nei cambi di scena e le lampade al neon, accese in sincrono e spente a canone fendono l’oscurità come per dare rilievo a certi accadimenti.
Se da un lato il contrasto tra un registro leggero e un soggetto drammatico risulta efficace, d’altra parte la recitazione sembra talvolta ammiccare al pubblico con le stesse mimiche e pause rubate dal medium televisivo. (Di rilievo Monica Iannessi, convincente nel ruolo di madre e moglie). La compagnia torinese sembra avere i presupposti per una ricerca che si confronti con la contemporaneità, sia nell’approccio con i testi, sia nell’uso di un linguaggio non ingessato e fruibile, senza sottrarsi ad un materia teatrale densa di significati. Penultimo spettacolo della rassegna teatrale Schegge, a cura della compagnia il Cerchio di Gesso, conferma il principio guida che sottosta alla rassegna: lavori accessibili ma di qualità.
La rassegna, giunta alla quarta edizione, non perde la sua venatura civile e l’attenzione alle giovani compagnie. Quest’anno, grazie alla vittoria del bando Da Giovane a Giovane, può permettersi di ospitare ben 4 compagnia under 35 con la possibilità di almeno una replica.Qui Beppe Casales ha festeggiato la centesima replica del suo “La spremuta”, e ancora “L’Italia è il paese che amo” di ReSpirale Teatro, “La protesta” de La Ballata dei Lenna, “I am Leto”di Rita Pelusio, solo per citare parte del cartellone. Quest’edizione vuole essere “Per un teatro felice”, nel senso della felice unione tra una qualità alta e dei costi accessibili per il pubblico (intento riuscito), ma nel dispiegarsi dei caratteri drammaturgici emerge un teatro incazzato, che non si adagia nell’esercizio di stile rassicurante, ma si sporca le mani nel confronto vivo con una materia che palpita.









 EMILIANA IACOVELLI | Oggi l’Italia si colloca, nel panorama internazionale, come Gresko nella difesa dell’Inter dell’anno calcistico 2001-2002: fuori posizione. Noi, popolo di poeti, santi, navigatori e calciofili, in questi anni non ci siamo fatti mancare niente: menestrello di corte, mutande verdi pagate con i danari dei contribuenti, corna immortalate nelle foto di rito a futura memoria, paragoni infelici in assemblee istituzionali con antieroi della storia, tentativi di eliminare, procurandogli un’angina pectoris, i competitors internazionali, patti scellerati con uomini di discutibile moralità.
EMILIANA IACOVELLI | Oggi l’Italia si colloca, nel panorama internazionale, come Gresko nella difesa dell’Inter dell’anno calcistico 2001-2002: fuori posizione. Noi, popolo di poeti, santi, navigatori e calciofili, in questi anni non ci siamo fatti mancare niente: menestrello di corte, mutande verdi pagate con i danari dei contribuenti, corna immortalate nelle foto di rito a futura memoria, paragoni infelici in assemblee istituzionali con antieroi della storia, tentativi di eliminare, procurandogli un’angina pectoris, i competitors internazionali, patti scellerati con uomini di discutibile moralità.