 ELENA SCOLARI | Tennessee Williams. Scrive in un’epoca di forte disincanto, in un’America che riflette su se stessa e sui propri modelli, e non ne esce niente bene. Confessiamo quindi che ci avviciniamo con qualche preoccupazione, sappiamo che non si tratta di un ottimista, che ha sofferto di depressione e che i suoi testi possono lasciare l’amaro in bocca.
ELENA SCOLARI | Tennessee Williams. Scrive in un’epoca di forte disincanto, in un’America che riflette su se stessa e sui propri modelli, e non ne esce niente bene. Confessiamo quindi che ci avviciniamo con qualche preoccupazione, sappiamo che non si tratta di un ottimista, che ha sofferto di depressione e che i suoi testi possono lasciare l’amaro in bocca.
Lo zoo di vetro è del 1945, ma ciò che vi è detto non è così legato a quegli anni, si osserva la condition humaine in un aspetto sempre attuale – la ricerca della felicità – che allontana la possibilità di risultare datato. Lo verifichiamo grazie alla messinscena di Arturo Cirillo e alla bellissima traduzione di Gerardo Guerrieri, mettiamo l’accento sul suo lavoro perché si tratta di un elemento determinante al successo dello spettacolo e alla dissipazione della nostra diffidenza: la traduzione non è solo buona tecnicamente ma è agile, credibile, ironica e intelligente, punto di forza che ci fa sentire i personaggi più vicini. Una famiglia con Amanda, una madre opprimente ma tanto sincera nella sua infantile fiducia, la figlia Laura, zoppa e timidissima, Tom, il figlio irrisolto e incazzoso, e il suo amico Jim, ritenuto per una sera pretendente della delicata Laura. Il padre se ne è andato anni fa, alcolista.
La vicenda è uno snodarsi di dialoghi quotidiani ma con alcune massime di portata aforistica (“Il futuro diventerà il presente, il presente passato e il passato un eterno rimpianto”), all’interno di casa Wingfield. Il nocciolo è trovare un fidanzato (e quindi un futuro marito) alla trasparente Laura, altrimenti condannata ad uno zitellaggio solitario, la madre suggerisce a Tom di invitare un amico a cena e in questa tragicomica serata vedremo ancora più chiaramente gli elementi del quadro: la nostalgia ossessiva di Amanda per la sua gioventù nell’abito assurdo che indosserà, l’egoismo di Tom che sta cercando la sua personale via d’uscita, l’impacciataggine patologica di Laura, che sviene alla vista di Jim e l’insospettata sensibilità di quest’ultimo che capirà la diversità della giovane donna, la sua fragilità unica e irripetibile. Jim non potrà diventare il suo fidanzato, lo sappiamo, ma per la durata di quella conversazione in cui lei si apre come mai le abbiamo visto fare, e in quei pochi e accennati passi di danza che sembrano un miracolo, anche noi ci crediamo. Fino alla rottura dell’unicorno. Laura ha il suo rifugio: una collezione di minuscoli animali di vetro (lo zoo), fragilissimi come lei ma che le fanno compagnia, a loro modo la proteggono perché lei sola li sa maneggiare, il preferito è un unicorno che cadrà nel momento vitale del ballo con Jim. Cadrà e naturalmente si romperà, perderà il corno ma “così non si sentirà più diverso dagli altri cavalli dello zoo”, dirà Laura. Forse anche lei si sentirà meno unicorno perché ha capito qualcosa che non aveva mai vissuto prima. Ci ricorda Pinocchio che diventa un bambino come tutti, ma col passato di Pinocchio, perché anche Laura rimarrà diversa ma più consapevole che questo non sia un difetto.
Lo spettacolo è ben recitato da tutti, Milvia Marigliano tratteggia un carattere buffo e materno, Monica Piseddu è una fantasmatica Laura, Edoardo Ribatto un Jim un po’ Fonzie ma attento e lo stesso regista Cirillo è divertente nella sua affezionata ribellione alla madre, forse butta un po’ via la tirata finale, togliendo drammaticità ad una chiusa altrimenti perfetta.
La scenografia è modesta, mobilio modesto ed essenziale, niente quinte, alcune grandi (e inutili) foto in bianco e nero con le facce dei personaggi, un grammofono che diffonderà solo canzoni di Luigi Tenco (un po’ ruffiano ma adatto). Questa ambientazione dimessa, come se fosse lì lì per scomparire, ci ha fatto pensare al genere di malinconia che sottende alla letteratura di Fitzgerald: la sensazione continua che tutto si perda nell’attimo in cui accade, nel costante sbriciolarsi della realtà tra le dita, la giovinezza senza tempo perché quando c’è non te ne rendi conto e quando la rivorresti è passata per sempre.







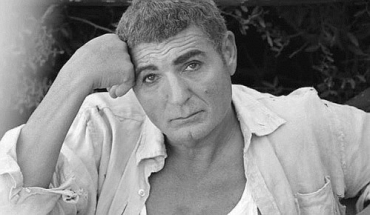
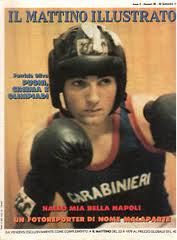 Troppo acerbo?
Troppo acerbo? EMANUELE TIRELLI | Se volessi pubblicare 300 copie del mio libro di 140 pagine, in bianco e nero, con una qualità di stampa standard, un tipo di carta crema con grammatura 70 g/mq di formato 15×21, con copertina a colori plastificata opaca e senza alette, morbida con brossura fresata con colla poliuretanica, verrebbe a costarmi 771,00 euro, iva esclusa.
EMANUELE TIRELLI | Se volessi pubblicare 300 copie del mio libro di 140 pagine, in bianco e nero, con una qualità di stampa standard, un tipo di carta crema con grammatura 70 g/mq di formato 15×21, con copertina a colori plastificata opaca e senza alette, morbida con brossura fresata con colla poliuretanica, verrebbe a costarmi 771,00 euro, iva esclusa.

 LAURA NOVELLI |
LAURA NOVELLI |