 NICOLA ARRIGONI | «La parola ‘teatro’ mi squarciò il cuore come uno squillo di tromba. La fantasia si risvegliò tutta d’un tratto. Ma la traccia che la fantasia poi seguì non fu quella che portava dietro al palco e che inseguito indirizza il fanciullo, ma quella delle persone serene e sagge, che avevano convinto i propri genitori a lasciarli andare a teatro al pomeriggio». Quanto scrive Walter Benjamin in Figure dell’infanzia. Educazione, letteratura, immaginario, volume a cura di Francesco Cappa e Martino Negri, pubblicato da Raffaello Cortina Editore (pagine 384, euro 17,50) permette di andare al cuore della natura bifronte che caratterizza il rapporto fra teatro ed educazione. Se da un lato, infatti, Benjamnin mette in evidenza che il teatro che porta dietro al palco indirizzi il fanciullo, lo faccia crescere, gli faccia fare esperienza, non meno importante sembra essere – e lo è – l’esperienza da spettatore laddove per Benjamin così descrive l’andare a teatro: «Vi si entrava attraverso una breccia nel tempo, distruggendo quella nicchia del giorno rappresentata dal pomeriggio, nella quale si assaporava già l’odore del lume e del coricarsi per la notte». E ancora piace sottolineare cosa il filosofo si aspettasse dall’essere a teatro: «Vi era piuttosto uno scopo più alto – rispetto a quello di assistere alo spettacolo -: essere seduto a teatro fra gli altri che erano lì». Si pone dunque l’accento sulla natura di esperienza comune che caratterizza sempre e comunque il rito teatrale che chiede di essere lì presenti, in quel momento, in quel preciso spazio per assistere a un racconto che è per sua natura condivisione di ascolto e partecipazione.
NICOLA ARRIGONI | «La parola ‘teatro’ mi squarciò il cuore come uno squillo di tromba. La fantasia si risvegliò tutta d’un tratto. Ma la traccia che la fantasia poi seguì non fu quella che portava dietro al palco e che inseguito indirizza il fanciullo, ma quella delle persone serene e sagge, che avevano convinto i propri genitori a lasciarli andare a teatro al pomeriggio». Quanto scrive Walter Benjamin in Figure dell’infanzia. Educazione, letteratura, immaginario, volume a cura di Francesco Cappa e Martino Negri, pubblicato da Raffaello Cortina Editore (pagine 384, euro 17,50) permette di andare al cuore della natura bifronte che caratterizza il rapporto fra teatro ed educazione. Se da un lato, infatti, Benjamnin mette in evidenza che il teatro che porta dietro al palco indirizzi il fanciullo, lo faccia crescere, gli faccia fare esperienza, non meno importante sembra essere – e lo è – l’esperienza da spettatore laddove per Benjamin così descrive l’andare a teatro: «Vi si entrava attraverso una breccia nel tempo, distruggendo quella nicchia del giorno rappresentata dal pomeriggio, nella quale si assaporava già l’odore del lume e del coricarsi per la notte». E ancora piace sottolineare cosa il filosofo si aspettasse dall’essere a teatro: «Vi era piuttosto uno scopo più alto – rispetto a quello di assistere alo spettacolo -: essere seduto a teatro fra gli altri che erano lì». Si pone dunque l’accento sulla natura di esperienza comune che caratterizza sempre e comunque il rito teatrale che chiede di essere lì presenti, in quel momento, in quel preciso spazio per assistere a un racconto che è per sua natura condivisione di ascolto e partecipazione.
In tutto questo ben si capisce come il teatro sia esperienza totalizzante, sia laboratorio del fare e dell’essere, in stretta connessione col mondo della scuola, malgrado rischi sempre e comunque di essere percepito come corpo estraneo. Da almeno trent’anni con vicende alterne, con protocolli di intesa fra ministeri o semplicemente con iniziative autonome portate avanti da uffici scolastici e teatri o assessorati alle politiche educative i laboratori teatrali nelle scuole italiane di ogni ordine e grado sono una realtà e si dimostrano mezzi formativi ed espressivi assolutamente unici ed efficaci in una scuola sempre più bisognosa di affinare le proprie dinamiche relazionali. A tracciare la parabola di questo strano rapporto, di questa coppia di fatto: teatro e scuola è Claudio Facchinelli nel volume Dramatopedia. Spunti di storia, etica e poetica per il teatro della scuola, volume pubblicato a Edizionicorsare (pagine 196, 10 euro). Claudio Facchinelli è stato dall’inizio degli anni Novanta un osservatore privilegiato del rapporto fra teatro e scuola, dai tempi dei primi progetti di Educazione alla salute ai tentativi di rendere curricolari le azioni teatrali nelle scuole, di questa vicenda artistica, politica, pedagogica Facchinelli traccia una sorta di excursus, attingendo a piene mani dall’esperienza personale di uomo di scuola e di critico militante, oltre che di organizzatore teatrale. Claudio Facchinelli prende in esame non solo il percorso normativo che ha portato il teatro a entrare nelle aule scolastiche, ne evidenzia le specifiche educative e le potenzialità espressive, senza dimenticare i nodi problematici che – spesso e volentieri guarda caso – riguardano più che altro il mondo degli aduli. Il difficile rapporto fra insegnanti e operatori, l’ansia da prestazione che la scuola di progetto richiede e che non è sempre necessaria quando non dannosa nel processo laboratoriale sono alcuni dei temi presi in esame.
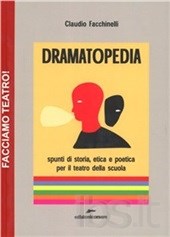 Insomma se il volume di Facchinelli traccia lo scenario della storia recente del rapporto fra scula e teatro Fabrizio Cassanelli e Guido Castiglia nel volume Il teatro del fare, pubblicato da Titivillus (pagine 210, 16 euro) non si limitano a descrivere metodologie di lavoro ed esperienze del teatro in classe on attenzione al comico e alle sue connessioni didattiche, ma si spingono oltre e propongono il ‘teatro’ come modello didattico per un nuovo modo di apprendimento, per far sì che l’esperire porti ad una conoscenza dei principi anche teorici basati sul fare. I due autori individuano «la possibilità per il teatro di presentarsi agli insegnanti e agli operatori come un’alternativa all’approccio della trasmissione frontale tradizionale proprio perché è un linguaggio interdisciplinare in grado di contendere dentro di sé il gesto, il movimento, il suono, la parola, l’immagine l segno che tiene conto delle ragioni e delle emozioni dei soggetti», scrivono i due autori. Ed è questa vocazione al fare, al condivider, al partecipare insieme che fa del linguaggio teatrale uno straordinario mezzo espressivo che permette di fare scuola con impegno e intelligenza, con anima e corpo, tenendo conto dell’altro e nel confronto con l’altro costruire la cognizione di sé. La scuola questo lo sa, e se pure con incostanza e in maniera del tutto autonoma, non manca di affidarsi al linguaggio della scena con entusiasmo e con risultati sempre spiazzanti e per questo utili. Ancora immaturo il progetto di fare di questo una costante, ma oggi – non solo nella scuola – le costanti sono la sperimentazione perenne, che on vuol dire ricerca ma piuttosto fare, andare in avanti in cerca prima o poi di un orizzonte condiviso e comune che non c’è. E questo non solo nella scuola.
Insomma se il volume di Facchinelli traccia lo scenario della storia recente del rapporto fra scula e teatro Fabrizio Cassanelli e Guido Castiglia nel volume Il teatro del fare, pubblicato da Titivillus (pagine 210, 16 euro) non si limitano a descrivere metodologie di lavoro ed esperienze del teatro in classe on attenzione al comico e alle sue connessioni didattiche, ma si spingono oltre e propongono il ‘teatro’ come modello didattico per un nuovo modo di apprendimento, per far sì che l’esperire porti ad una conoscenza dei principi anche teorici basati sul fare. I due autori individuano «la possibilità per il teatro di presentarsi agli insegnanti e agli operatori come un’alternativa all’approccio della trasmissione frontale tradizionale proprio perché è un linguaggio interdisciplinare in grado di contendere dentro di sé il gesto, il movimento, il suono, la parola, l’immagine l segno che tiene conto delle ragioni e delle emozioni dei soggetti», scrivono i due autori. Ed è questa vocazione al fare, al condivider, al partecipare insieme che fa del linguaggio teatrale uno straordinario mezzo espressivo che permette di fare scuola con impegno e intelligenza, con anima e corpo, tenendo conto dell’altro e nel confronto con l’altro costruire la cognizione di sé. La scuola questo lo sa, e se pure con incostanza e in maniera del tutto autonoma, non manca di affidarsi al linguaggio della scena con entusiasmo e con risultati sempre spiazzanti e per questo utili. Ancora immaturo il progetto di fare di questo una costante, ma oggi – non solo nella scuola – le costanti sono la sperimentazione perenne, che on vuol dire ricerca ma piuttosto fare, andare in avanti in cerca prima o poi di un orizzonte condiviso e comune che non c’è. E questo non solo nella scuola.
Per questo il teatro può declinarsi al plurale e diventare Teatri Re-esistenti come recita l titolo del volume a cura di Laura Gobbi e Federica Zanetti, pubblicato da Titivillus (pagine 164, 16 euro) in cui l’esperienza della scena e del teatro laboratoriali vengono letti come strumenti per l’invenzione di un nuovo senso di cittadinanza, una cittadinanza attiva che si esprime attraverso quell’apparente surplus di finzione che regala il teatro e che in realtà va a incidere sulla realtà e la coscienza che noi abbiamo del mondo che viviamo. Per questo motivo il teatro laddove viene meno la democrazia è oscurato, osteggiato, vessato perché è strumento di partecipazione, è pungolo alla coscienza, è idea che agisce e trasforma… a scuola come nell’ambito sociale.
Walter Benjamin, Figure dell’infanzia. Educazione, letteratura, immaginario, volume a cura di Francesco Cappa e Martino Negri, Raffaello Cortina Editore, pagine 384, euro 17,50
Claudio Facchinelli, Dramatopedia. Spunti di storia, etica e poetica per il teatro della scuola, Edizionicorsare, pagine 196, 10 euro.
Frabrizio Cassanelli e Guido Castiglia, Il teatro del fare, Titivillus, pagine 210, 16 euro
Laura Gobbi e Federica Zanetti, a cura di, Teatri Re-esistenti. Confronti su teatro e cittadinanze, Titivillus, pagine 164, 16 euro

 LAURA NOVELLI | Parola scritta e parola recitata, pronunciata, porta al pubblico/uditorio. L’impressione più vivida che resta dopo il reading con cui Elio De Capitani e Ferdinando Bruni hanno aperto la rassegna romana “Il Garofano Verde. Scenari di teatro omosessuale” è quella di una ricerca verbale e testuale che recuperi alla scena la sacralità del dire e la raffinatezza di un raccontare con intelligenza, originalità, arguzia, consapevolezza, bellezza. Non si tratta solo, cioè, di scegliere autori “sicuri” in tal senso – il cartellone di questa ventesima edizione, per esempio, assembla, insieme con questo Alan Bennett iniziale, due intellettuali italiani molto diversi tra loro come Giovanni Testori (sulle cui poesie religiose raccolte in “Nel tuo sangue” e “Ossa mea” si concentra l’intervento di Valter Malosti) e Walter Siti (di cui Massimo Popolizio affronta uno dei racconti de “La magnifica merce”) – ma si tratta anche di convogliare traduttori, registi, artisti, attori capaci di dare un “come” decoroso alla “cosa” detta. Per cui, è vero, nel caso di “Il vizio dell’arte” di Bennett (titolo originale, “The Habit of Art”) parliamo di reading, di lettura, ma in realtà dentro quella mise en espace c’è già un’aura di spettacolo, un senso interpretativo forte, un’armonia di segni e significati, un’idea compositiva chiara.
LAURA NOVELLI | Parola scritta e parola recitata, pronunciata, porta al pubblico/uditorio. L’impressione più vivida che resta dopo il reading con cui Elio De Capitani e Ferdinando Bruni hanno aperto la rassegna romana “Il Garofano Verde. Scenari di teatro omosessuale” è quella di una ricerca verbale e testuale che recuperi alla scena la sacralità del dire e la raffinatezza di un raccontare con intelligenza, originalità, arguzia, consapevolezza, bellezza. Non si tratta solo, cioè, di scegliere autori “sicuri” in tal senso – il cartellone di questa ventesima edizione, per esempio, assembla, insieme con questo Alan Bennett iniziale, due intellettuali italiani molto diversi tra loro come Giovanni Testori (sulle cui poesie religiose raccolte in “Nel tuo sangue” e “Ossa mea” si concentra l’intervento di Valter Malosti) e Walter Siti (di cui Massimo Popolizio affronta uno dei racconti de “La magnifica merce”) – ma si tratta anche di convogliare traduttori, registi, artisti, attori capaci di dare un “come” decoroso alla “cosa” detta. Per cui, è vero, nel caso di “Il vizio dell’arte” di Bennett (titolo originale, “The Habit of Art”) parliamo di reading, di lettura, ma in realtà dentro quella mise en espace c’è già un’aura di spettacolo, un senso interpretativo forte, un’armonia di segni e significati, un’idea compositiva chiara.
 Anche in questi progetti si può dunque intercettare quella contaminazione di generi che caratterizza da sempre Short Theatre?
Anche in questi progetti si può dunque intercettare quella contaminazione di generi che caratterizza da sempre Short Theatre?
 NICOLA ARRIGONI | Una serie di sedie ai lati del palco, quando gli spettatori entrano gli attori sono già in scena. Antonio Gargiulo, Valentina Picello, Roberta Rovelli e Roberto Rustioni si muovono nervosi, sciolgono il corpo, in una sorta di riscaldamento pre-icontro, in una sorta di training mente/corpo. Eh sì perché lo spazio scenico di Tre atti unici può richiamare una sorta di ring e al tempo stesso nulla concede alla verosimiglianza e tutto alla finzione in quel preparare la scena che è come dire: qui si fa teatro. Un movimento di danza che pone elegantemente in evidenza tic, nevrosi di quei personaggi che sono lì pronti a sfidarsi, a mettere in atto il loro duello con la vita e al tempo stesso sono attori che vestono i panni di personaggi, una pausa, uno sguardo d’intesa, e si va a cominciare.
NICOLA ARRIGONI | Una serie di sedie ai lati del palco, quando gli spettatori entrano gli attori sono già in scena. Antonio Gargiulo, Valentina Picello, Roberta Rovelli e Roberto Rustioni si muovono nervosi, sciolgono il corpo, in una sorta di riscaldamento pre-icontro, in una sorta di training mente/corpo. Eh sì perché lo spazio scenico di Tre atti unici può richiamare una sorta di ring e al tempo stesso nulla concede alla verosimiglianza e tutto alla finzione in quel preparare la scena che è come dire: qui si fa teatro. Un movimento di danza che pone elegantemente in evidenza tic, nevrosi di quei personaggi che sono lì pronti a sfidarsi, a mettere in atto il loro duello con la vita e al tempo stesso sono attori che vestono i panni di personaggi, una pausa, uno sguardo d’intesa, e si va a cominciare.



 GIULIA MURONI | Fuori dalla crisi con uno sguardo verso l’esterno che oltrepassi gli orizzonti stagnanti e i tavoli da gioco protetti dai confini del territorio. La formula di Gigi Cristoforetti, direttore artistico del Torinodanza Festival, si esprime in una trasformazione dell’identità del festival nell’ottica di un progetto dal respiro europeo. Le numerose collaborazioni e la speciale connessione con Lyon hanno creato un terreno solido su cui costruire un comune sentire sociale e artistico. L’inaugurazione di venerdì 13 alle Fonderie Limone a Moncalieri si è articolata in due parti: lo spettacolo dell’italiano Emio Greco e “Elégie” del francese Olivier Dubois, entrambi messi in scena dal Balletto di Marsiglia.
GIULIA MURONI | Fuori dalla crisi con uno sguardo verso l’esterno che oltrepassi gli orizzonti stagnanti e i tavoli da gioco protetti dai confini del territorio. La formula di Gigi Cristoforetti, direttore artistico del Torinodanza Festival, si esprime in una trasformazione dell’identità del festival nell’ottica di un progetto dal respiro europeo. Le numerose collaborazioni e la speciale connessione con Lyon hanno creato un terreno solido su cui costruire un comune sentire sociale e artistico. L’inaugurazione di venerdì 13 alle Fonderie Limone a Moncalieri si è articolata in due parti: lo spettacolo dell’italiano Emio Greco e “Elégie” del francese Olivier Dubois, entrambi messi in scena dal Balletto di Marsiglia.