 ALESSANDRO MASTANDREA | In principio era “Non è mai troppo tardi” di Alberto Manzi. Oggi invece, esplorati da tempo i territori del tragico e sperimentati sulla viva pelle degli spettatori mimesi e catarsi, la TV ha abbassato le proprie ambizioni rivolgendo lo sguardo altrove, verso attività ben più mondane.
ALESSANDRO MASTANDREA | In principio era “Non è mai troppo tardi” di Alberto Manzi. Oggi invece, esplorati da tempo i territori del tragico e sperimentati sulla viva pelle degli spettatori mimesi e catarsi, la TV ha abbassato le proprie ambizioni rivolgendo lo sguardo altrove, verso attività ben più mondane.
La componente educativa, infatti, ha trovato una singolare valvola di sfogo in ambiti sempre più specialistici: dai segreti della decorazione di torte e affini, all’organizzazione di un party impeccabile, fino alla scelta del perfetto abito da sposa, tutte esigenze indissolubilmente legate alla condizione umana, dalla cui risoluzione dipende senza ombra di dubbio l’equilibrio della nostra sfera emotiva. La cura del corpo e del proprio vestiario, del famigerato “outfit” per dirla con terminologia tecnica, non è da meno.
In tale ambito, meta imprescindibile di pellegrinaggio mediatico, per tutti i cultori dello stile via etere, è la chicchissima “Ma come ti vesti!?”.
La premessa è semplice: se le vicende della vita hanno portato un tuo congiunto a smarrire la retta via dell’eleganza, non c’è altra soluzione se non affidarsi, con sguardo mesto e animo contrito, ai due santoni della passerella da studio televisivo, all’appello Miccio Enzo e Gozzi Carla, sperando nella grazia. Sono oramai sette anni che la caleidoscopica esperienza nei dedali del fashion style, offerta dai due, miete vittime senza posa. D’altro canto, un guardaroba ben assortito val bene una o due crisi d’identità. Ebbene, non paghi di tanti anni di successi, le instancabili menti di Discovery Italy, hanno pensato bene allo spin-off: “Guardaroba perfetto, kids & teen”. E la polemica infuria implacabile in rete. Abbandonato il “fido Miccio” (il gioco di parole animale è casuale) è la sola Gozzi a farsi carico della pesante eredità. Sulle sue spalle l’ingrato fardello di educare al buon gusto le masse di bambini e teen ager, con l’ausilio dell’immancabile spalla, Enza: castigata, la poveretta, in un bianco camice da sarta, cui solo un fazzoletto nero al collo dona quel minimo di brio.
Ora, che tra il Miccio e la Gozzi, quello simpatico sia il primo, è fuor di dubbio. Le sue metafore ardite valgono da sole il tempo della trasmissione: “vestita così, bella mia, sembri un lottatore di sumo”. Ma le ferree leggi della fascia oraria non permettono deroghe. Un bambino avviato sulla strada dell’omologazione non ha mai fatto male a nessuno, ma i consigli à la page di un esperto stylist gay a degli inermi teen-ager, non stanno per niente bene a tavola.
Ma a noi, in fondo, la Carla Gozzi piace anche da sola: le sue pose da vecchia governante tedesca e quel singolare vezzo di parlare tenendo le labbra perennemente socchiuse ci hanno irrimediabilmente contagiati.
Così come siamo contagiati dal tono allegro della trasmissione e dal “gioco della moda”, come lo chiama lei, alla faccia di petizioni, polemiche e fobie da omologazioni varie. “Carla aiutaci tu”, urlano i genitori in crisi. E la nostra super-donna si precipita in loco, con la coda platinata sempre in ordine, a dispensar consigli. Alle sprovvedute kids & teen non è dato nemmeno il tempo di reagire, che lei, sorta di irrefrenabile uragano di simpatia, ha già messo a soqquadro il loro guardaroba: “Sai cosa facciamo adesso? Liberiamo tutto il guardaroba e lanciamo tutti i vestiti sul letto!”-“ Ah divertente” risponde Matilde, 14 anni, da Milano, sguardo tra lo smarrito e attonito. La moda sarà pure un gioco, ma di certo non è uno scherzo. Occorrono infatti doti da psicologa, oltre naturalmente a una simbiosi perfetta con quel flusso di energia primordiale che è lo stile e i suoi accostamenti. Che importa poi se i risultati non sempre vengono apprezzati – “Questo non mi piace… è un po’ antico”- in fondo, sono solo ragazzi.
Già assediati da pubblicità e subdole strategie di marketing ( peer-to-peer, insiders, trandspotters, seeding) ai nostri poveri pargoli tocca anche sciropparsi i consigli dell’inflessibile governante. “Carla Consiglia: mai parlare alle orecchie delle amiche”. Non bastassero, dunque, le tempeste ormonali, i rapporti conflittuali con genitori e insegnanti e i cambiamenti del proprio corpo da accettare e gestire, ora dovranno guardarsi anche da “Guardaroba perfetto kids & teen”. Quando si dice “piove sempre sul bagnato”.
Qualche parodia…
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TkSeHGFuQgg&w=560&h=315]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=g1FtfntA1no&w=560&h=315]


 MARIA CRISTINA SERRA | Sono stretti l’uno all’altro sotto teli di plastica nera, gioielli preziosi gettati via insieme alla spazzatura. I bambini dei sobborghi di Damasco giacciono allineati, avvolti nei loro stracci colorati, con le braccia incrociate sul petto, come in un’ultima difesa della vita. Immobili nel loro ultimo sonno sotto un infinito lenzuolo bianco, che lascia scoperti solo i volti di un’infanzia violata.
MARIA CRISTINA SERRA | Sono stretti l’uno all’altro sotto teli di plastica nera, gioielli preziosi gettati via insieme alla spazzatura. I bambini dei sobborghi di Damasco giacciono allineati, avvolti nei loro stracci colorati, con le braccia incrociate sul petto, come in un’ultima difesa della vita. Immobili nel loro ultimo sonno sotto un infinito lenzuolo bianco, che lascia scoperti solo i volti di un’infanzia violata. I rullini rimediati a fatica, la difficoltà di sviluppare e stampare: una lotta contro il tempo a rischio della vita, così per i visitatori che andavano alle sue mostre, per condividere la comune sofferenza. Disperazione e pudore, tenerezza e atrocità, paura e rassegnazione entrano nelle inquadrature e compongono l’insieme, immortalando quello che è avvenuto in un solo istante. L’artista ha immagazzinato pagine di Storia per la sua gente e per noi, per aiutarci a “vedere” la nostra contemporaneità, la realtà bulimica del Male e la sua insaziabile ripetitività. I conflitti separano le comunità e ne unificano le tragedie.
I rullini rimediati a fatica, la difficoltà di sviluppare e stampare: una lotta contro il tempo a rischio della vita, così per i visitatori che andavano alle sue mostre, per condividere la comune sofferenza. Disperazione e pudore, tenerezza e atrocità, paura e rassegnazione entrano nelle inquadrature e compongono l’insieme, immortalando quello che è avvenuto in un solo istante. L’artista ha immagazzinato pagine di Storia per la sua gente e per noi, per aiutarci a “vedere” la nostra contemporaneità, la realtà bulimica del Male e la sua insaziabile ripetitività. I conflitti separano le comunità e ne unificano le tragedie. I contrasti del bianconero, le luci fuse alle ombre, proiettano il dolore nei nostri occhi: un cane è come spezzato in due, confuso col brecciolino; sull’asfalto le schegge di una granata si spargono a corona; il cadavere del giornalista di Radio Sarajevo, Zeljko Ruzicic, giace con le ginocchia ripiegate e la borsa di lavoro sul petto. Gli scheletri dei palazzi sventrati, i resti della biblioteca Nazionale, il tram ridotto a ferraglia contorta. Le rovine delle chiese e delle mosche che si stagliano in controluce, mostrandoci la loro magnificenza profanata e l’intreccio di culture secolari, disintegrate per sempre. Poi, le madri e i figli, ritratti di dolente bellezza caravaggesca. E i bambini, vittime assolute di tutte le guerre: guardano dai finestrini dei bus che li portano lontano dalla città assediata; giocano alla guerra con finte armi di plastica e di legno; fissano l’obiettivo con aria di sfida; si rifugiano fra le gambe dei padri; guardano il loro futuro negato oltre una fitta rete, rannicchiati sulla bicicletta, la fronte aggrottata come vecchi.
I contrasti del bianconero, le luci fuse alle ombre, proiettano il dolore nei nostri occhi: un cane è come spezzato in due, confuso col brecciolino; sull’asfalto le schegge di una granata si spargono a corona; il cadavere del giornalista di Radio Sarajevo, Zeljko Ruzicic, giace con le ginocchia ripiegate e la borsa di lavoro sul petto. Gli scheletri dei palazzi sventrati, i resti della biblioteca Nazionale, il tram ridotto a ferraglia contorta. Le rovine delle chiese e delle mosche che si stagliano in controluce, mostrandoci la loro magnificenza profanata e l’intreccio di culture secolari, disintegrate per sempre. Poi, le madri e i figli, ritratti di dolente bellezza caravaggesca. E i bambini, vittime assolute di tutte le guerre: guardano dai finestrini dei bus che li portano lontano dalla città assediata; giocano alla guerra con finte armi di plastica e di legno; fissano l’obiettivo con aria di sfida; si rifugiano fra le gambe dei padri; guardano il loro futuro negato oltre una fitta rete, rannicchiati sulla bicicletta, la fronte aggrottata come vecchi.

 RENZO FRANCABANDERA | E’ una rilettura de I Giusti di Camus sicuramente di giovanile compattezza quella di recente proposta la Piccola Compagnia Stabile – SR di Brescia durante “Ecce Histrio!” rassegna di compagnie emergenti, nel capoluogo lombardo.
RENZO FRANCABANDERA | E’ una rilettura de I Giusti di Camus sicuramente di giovanile compattezza quella di recente proposta la Piccola Compagnia Stabile – SR di Brescia durante “Ecce Histrio!” rassegna di compagnie emergenti, nel capoluogo lombardo.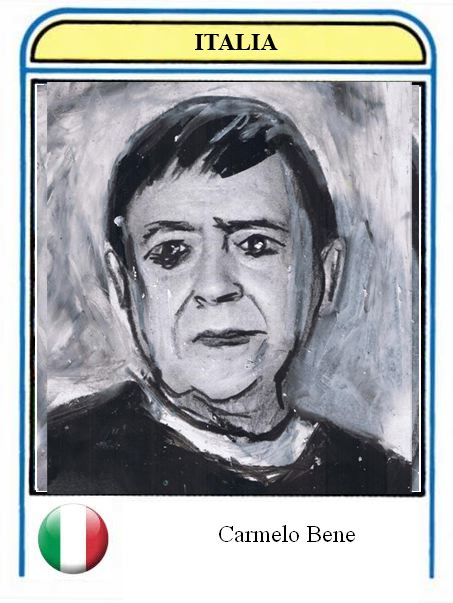
 Si può parlare di Bene senza rischiare di annoiare o sembrare un po’ retrò? I personaggi totalizzanti ritiene possano essere misura del tempo presente o studiarli serve anche ad andare oltre? E se si cosa c’è oltre Bene?
Si può parlare di Bene senza rischiare di annoiare o sembrare un po’ retrò? I personaggi totalizzanti ritiene possano essere misura del tempo presente o studiarli serve anche ad andare oltre? E se si cosa c’è oltre Bene? RENZO FRANCABANDERA | La ninfa undicenne arriva in monopattino da fondo scena, attraversando la sala illuminata da un faro, mentre l’adulta ha appena finito di elencare la “babilonica” tassonomia di punti di vista, pareri, voci di popolo sul personaggio di Lolita: dal chi non ne sa, al chi la vive nel suo immaginario; la bambina è nell’età di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, dove alcuni gesti iniziano a vivere il crinale dell’equivoco, diventa oggetto (e soggetto?) di seduzione. Come le more addentate dallo spiedino, gesto innocente e capace di un potenziale di provocazione adulta di cui chi lo pone in essere (e non parliamo qui della giovane attrice ma di ogni ragazzina di quell’età) può o meno essere consapevole, tutto in quell’età diventa ambiguo. Il corpo cambia, porta i segni dell’età feconda della specie umana, che socialmente si sposta vicino ai 40 anni, ma nella dinamica sessuale inizia invece prestissimo. Sempre più, in un’iconografia di diari, lucchetti, post-it, sms, canzoni di x-factor, fra bambine-ragazze, che giocano con le bolle di sapone e indossano capi di abbigliamento che le trasformano in signorine, che vanno in palestra di karate e di colpo ti sembrano Uma Thurman in Kill Bill, pronte a combattere per la vita.
RENZO FRANCABANDERA | La ninfa undicenne arriva in monopattino da fondo scena, attraversando la sala illuminata da un faro, mentre l’adulta ha appena finito di elencare la “babilonica” tassonomia di punti di vista, pareri, voci di popolo sul personaggio di Lolita: dal chi non ne sa, al chi la vive nel suo immaginario; la bambina è nell’età di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, dove alcuni gesti iniziano a vivere il crinale dell’equivoco, diventa oggetto (e soggetto?) di seduzione. Come le more addentate dallo spiedino, gesto innocente e capace di un potenziale di provocazione adulta di cui chi lo pone in essere (e non parliamo qui della giovane attrice ma di ogni ragazzina di quell’età) può o meno essere consapevole, tutto in quell’età diventa ambiguo. Il corpo cambia, porta i segni dell’età feconda della specie umana, che socialmente si sposta vicino ai 40 anni, ma nella dinamica sessuale inizia invece prestissimo. Sempre più, in un’iconografia di diari, lucchetti, post-it, sms, canzoni di x-factor, fra bambine-ragazze, che giocano con le bolle di sapone e indossano capi di abbigliamento che le trasformano in signorine, che vanno in palestra di karate e di colpo ti sembrano Uma Thurman in Kill Bill, pronte a combattere per la vita.

 ALESSANDRO MASTANDREA | Una parabola davvero insolita, quella tracciata dalla carriera televisiva di Luca Telese. Tanto insolita da non poter essere inquadrata sotto la sola lente del giornalismo televisivo. E’ infatti grazie alle sue naturali doti istrioniche che, nel corso degli anni, ha potuto dar prova delle sue indubbie capacità di grande attore, spaziando con disinvoltura tra generi assai diversi: dalla commedia all’italiana, alla tragedia esistenziale, non disdegnando tuttavia le sponde più leggere tipiche della sit-com.
ALESSANDRO MASTANDREA | Una parabola davvero insolita, quella tracciata dalla carriera televisiva di Luca Telese. Tanto insolita da non poter essere inquadrata sotto la sola lente del giornalismo televisivo. E’ infatti grazie alle sue naturali doti istrioniche che, nel corso degli anni, ha potuto dar prova delle sue indubbie capacità di grande attore, spaziando con disinvoltura tra generi assai diversi: dalla commedia all’italiana, alla tragedia esistenziale, non disdegnando tuttavia le sponde più leggere tipiche della sit-com. GIULIA MURONI | “Che bello che animate questo posto! In questa piazza non si fa mai nulla. A parte le celebrazioni per la festa dei morti….” Ci fa venire un po’ i brividi l’affermazione della cordiale signora di Esterzili. La festa dei morti. Mi trovo a pensare che in fondo molti spettacoli non siano altro che cerimonie di morte. Coazioni a ripetere di maniera, senza vita, senza arte.
GIULIA MURONI | “Che bello che animate questo posto! In questa piazza non si fa mai nulla. A parte le celebrazioni per la festa dei morti….” Ci fa venire un po’ i brividi l’affermazione della cordiale signora di Esterzili. La festa dei morti. Mi trovo a pensare che in fondo molti spettacoli non siano altro che cerimonie di morte. Coazioni a ripetere di maniera, senza vita, senza arte.