 ALESSANDRO MASTANDREA | “Questo hamburger è offensivo a me e a tutti i cittidini americani. Fa schifo, è una merda”, e giù il piatto nella pattumiera. Se mai il lancio del piatto di porcellana divenisse specialità olimpica, Joe Bastianich avrebbe buone possibilità di vittoria. Figlio d’arte e migrante di ritorno, il Moriconi Nando della ristorazione internazionale, forma assieme a Carlo Cracco e Bruno Barbieri il trio più temuto d’Italia, secondo solo – per rimanere in ambito cinematografico- alle “tre madri” della famosa trilogia di Dario Argento. Pur avendo ben poco di atletico, Masterchef ha tutti i connotati di una vera e propria gara, disseminata di insidie e ostacoli dietro ogni angolo, una lotta contro il tempo e contro i climi torridi di una “cucina infernale”.
ALESSANDRO MASTANDREA | “Questo hamburger è offensivo a me e a tutti i cittidini americani. Fa schifo, è una merda”, e giù il piatto nella pattumiera. Se mai il lancio del piatto di porcellana divenisse specialità olimpica, Joe Bastianich avrebbe buone possibilità di vittoria. Figlio d’arte e migrante di ritorno, il Moriconi Nando della ristorazione internazionale, forma assieme a Carlo Cracco e Bruno Barbieri il trio più temuto d’Italia, secondo solo – per rimanere in ambito cinematografico- alle “tre madri” della famosa trilogia di Dario Argento. Pur avendo ben poco di atletico, Masterchef ha tutti i connotati di una vera e propria gara, disseminata di insidie e ostacoli dietro ogni angolo, una lotta contro il tempo e contro i climi torridi di una “cucina infernale”.
Non c’è spazio per perdenti e “dilusioni”, nella master class dei tre famosi giudici si gareggia per vincere, perché alla fine “ne rimarrà uno solo” ad accaparrarsi il “malloppo”.
E’ lo spirito dell’autoaffermazione e del primato a ogni costo che innerva i talent show, e MasterChef in particolare. Evoluzione e superamento dei vecchi format che hanno costellato l’esperienza televisiva dello scorso decennio, questi “reality 2.0” rifuggono come la peste “l’uomo senza qualità”, allora così ricercato, per qualcuno che invece si faccia portatore del saper fare. Tanto caro a questa fase politica di “larghe intese”, “il fare” assurge a vera e propria categoria dello spirito, mezzo imprescindibile per la vittoria finale e il primato, segno di appartenenza all’elite dei vincenti e predestinati. Da dove provenga questa richiesta incessante di cucina non è dato sapersi, eppure, a dispetto di ritmi di vita sempre più serrati che con la cucina mal si conciliano, l’arte culinaria è al centro di un’offerta mediatica tra le più intense, con il talent suddetto quale punta di diamante. Il cibo e la cucina –inteso come luogo fisico- in Mastechef assumono un doppia valenza: quello di ambiente familiare, caldo e inclusivo, e di cibo come elemento accomunante legato al piacere e alla sussistenza, ma anche luogo in cui la temperatura da tiepida e familiare vira al calor bianco. Dove, a suon di cucchiarelle in legno, si consumano le più accese rivalità, la lotta per il primato si gioca senza esclusione di colpi e le strategie si fanno spietate. Ambiziosi e determinati i concorrenti di Masterchef volano alto con le ricette, così come i tre giudici con le metafore: “il tuo foie gras è come macchina d’epoca, spande olio dappertutto”.
Ma il format ideato dal britannico Franc Roddam riflette anche un altro tipo di metafora, che difficilmente riusciremmo a cogliere senza guardare a Tiziana Stefanelli, vincitrice della seconda edizione. Avvocato di successo, moglie e madre di famiglia, da subito conquista il cuore di pietra dello chef Cracco, forse per le sue indubbie doti di angelo del focolare: “Io e Andrea siamo rivali, quindi lo squarterò”; “ A mia figlia dico sempre che l’importante è partecipare, ma noi tutti sappiamo che l’importante è vincere”. Ma si sa, i sani principi da soli non bastano a dar conto di una vittoria, e nel caso specifico potrebbe essere necessario scomodare nientemeno che Max Weber. Sbaglieremmo poi tanto se affermassimo che M-Chef riflette quella stessa etica protestante, di matrice calvinista, che nel famoso saggio del sociologo tedesco è individuata quale causa dello sviluppo capitalistico occidentale? In quest’ottica il successo non risulta più fine a se stesso, ma diviene anch’esso il segno della grazia divina operante su colui che alla vittoria è stato predestinato. E le parole della vincitrice si caricano quindi di nuove sfumature: “qualsiasi cosa si può fare nella vita, basta crederci tanto e avere determinazione”; “A vincere mi sento nel mio”. Per l’ignaro semifinalista Andrea, la sorte aveva già deciso. Le aspirazioni a un cambiamento, a una svolta nella propria esistenza, non potevano che infrangersi contro la coscienza della predestinazione, di un’appartenenza alla stessa elite dei tre chef -giudici che tutti ammirano.
 Grazie alla forza omologante dei format, l’etica protestante di cui Weber parla, pare aver trovato il proprio luogo ideale in cucina, contagiando perfino noi italiani, popolo fiero delle proprie tradizioni gastronomiche e dalla cultura cattolica. In questo clima di contrapposizione tra riforma e controriforma culinaria, che molto occhieggia al passato, quella che qui definiamo l’etica cattolica non poteva non abbozzare una contromossa, affidandosi alla veterana dei fornelli raccontati, Antonella Clerici e al superchef Davide Scabin. Ne la loro Terra dei cuochi, all’aria spietata tipica dei talent, si sostituisce il più nostrano clima alla “volemose bene”. E la differenza si vede, soprattutto nella sorte riservata ai non meritevoli. Se nel format anglosassone sono sottoposti a una vera e propria espulsione dal “corpo” della trasmissione, attraverso un angusto corridoio che tanto assomiglia a un budello, ne La Terra dei cuochi, il perdente, pur nella sconfitta, è comunque riammesso in studio dalla puntata successiva, sorta di perdono ricevuto dai due sacerdoti officianti. Scabin diviene il difensore della tradizione gastronomica italiana, mentre il manto di giudici implacabili è vestito nientemeno che dai familiari dei concorrenti, chiamati a deciderne le sorti. A completare il quadretto familiare, vi sono gli assistenti-padrini. Dall’indubbio blasone televisivo, costoro si caricano della stessa valenza religiosa di coloro che accompagnano i novizi verso i sacramenti più importanti, oppure, più pragmaticamente, di introdurre i concorrenti nel difficile mondo del madia televisivo, consiglieri e raccomandatori al contempo.
Grazie alla forza omologante dei format, l’etica protestante di cui Weber parla, pare aver trovato il proprio luogo ideale in cucina, contagiando perfino noi italiani, popolo fiero delle proprie tradizioni gastronomiche e dalla cultura cattolica. In questo clima di contrapposizione tra riforma e controriforma culinaria, che molto occhieggia al passato, quella che qui definiamo l’etica cattolica non poteva non abbozzare una contromossa, affidandosi alla veterana dei fornelli raccontati, Antonella Clerici e al superchef Davide Scabin. Ne la loro Terra dei cuochi, all’aria spietata tipica dei talent, si sostituisce il più nostrano clima alla “volemose bene”. E la differenza si vede, soprattutto nella sorte riservata ai non meritevoli. Se nel format anglosassone sono sottoposti a una vera e propria espulsione dal “corpo” della trasmissione, attraverso un angusto corridoio che tanto assomiglia a un budello, ne La Terra dei cuochi, il perdente, pur nella sconfitta, è comunque riammesso in studio dalla puntata successiva, sorta di perdono ricevuto dai due sacerdoti officianti. Scabin diviene il difensore della tradizione gastronomica italiana, mentre il manto di giudici implacabili è vestito nientemeno che dai familiari dei concorrenti, chiamati a deciderne le sorti. A completare il quadretto familiare, vi sono gli assistenti-padrini. Dall’indubbio blasone televisivo, costoro si caricano della stessa valenza religiosa di coloro che accompagnano i novizi verso i sacramenti più importanti, oppure, più pragmaticamente, di introdurre i concorrenti nel difficile mondo del madia televisivo, consiglieri e raccomandatori al contempo.
D’altro canto nella cattolicissima Italia è così che funziona: senza raccomandazione non si va da nessuna parte. Neanche in cucina.

 SABRINA VEDOVOTTO | Di tempo ne è passato a sufficienza per poter fare una analisi lucida e il più possibile oggettiva. Mai come quest’anno si è attesa tanto la preview della Biennale di Venezia. Già, perché è di questo che ci accingiamo a parlare. Una Biennale dalle aspettative incredibili, vuoi per il nome del curatore italiano, Massimiliano Gioni, vuoi per la sua giovane età, ma soprattutto per la mole di personaggi invitati, non tutti artisti. Ma di questo si è già detto. Il palazzo enciclopedico, questo il titolo della grande mostra, non tutti artisti, non tutti vivi, molti artigiani, molte persone al di fuori di ogni contesto artistico etc etc.
SABRINA VEDOVOTTO | Di tempo ne è passato a sufficienza per poter fare una analisi lucida e il più possibile oggettiva. Mai come quest’anno si è attesa tanto la preview della Biennale di Venezia. Già, perché è di questo che ci accingiamo a parlare. Una Biennale dalle aspettative incredibili, vuoi per il nome del curatore italiano, Massimiliano Gioni, vuoi per la sua giovane età, ma soprattutto per la mole di personaggi invitati, non tutti artisti. Ma di questo si è già detto. Il palazzo enciclopedico, questo il titolo della grande mostra, non tutti artisti, non tutti vivi, molti artigiani, molte persone al di fuori di ogni contesto artistico etc etc. Una volta usciti dalle sale della grande mostra, tutto ciò che è stato appena detto perde di senso e significato, perché i padiglioni non sono solo intimi e riflessivi, ma sono soprattutto molto proiettati verso la realtà contingente. Chi con opere dirette, chi con discorsi edulcorati, molti artisti hanno infatti scelto di raccontare cosa sta succedendo. Hic et nunc.
Una volta usciti dalle sale della grande mostra, tutto ciò che è stato appena detto perde di senso e significato, perché i padiglioni non sono solo intimi e riflessivi, ma sono soprattutto molto proiettati verso la realtà contingente. Chi con opere dirette, chi con discorsi edulcorati, molti artisti hanno infatti scelto di raccontare cosa sta succedendo. Hic et nunc. ANTONELLA POLI | « Regarder parfois voir », ci dice Jacques Borgetto durante il nostro incontro dell’11 giugno scorso. Parigi é la sua citta. Ma lui é il fotografo dei viaggi, dei paesaggi e degli animali. La fotografia é stata da sempre il suo mestiere come lo stesso autore afferma. Quest’arte gli dà la possibilità di concretizzare in immagini la sua sensibilità verso gli esseri umani, di cogliere le luci e la forza della natura , di scrutare al di là degli sguardi di un semplice cane. Di origine italiana, (suo nonno paterno era piemontese), ha cominciato a viaggiare molto presto per mettere al servizio del suo “occhio” acuto la sua caméra. Fedele alla tecnica tradizionale dell’argentique, oggi Jacques Borgetto si é aperto anche al digitale, senza che il suo stile sia cambiato. L’Argentina, il Cile, il Tibet, il Mali sono state le sue mete importanti che gli hanno permesso di descrivere con un realismo acuto queste parti del mondo lontane dalla sua Francia mettendone in rilievo gli aspetti più nascosti, inconsueti e soprattutto fotogrando e immortalando l’anima delle popolazioni che incontrava sul suo cammino. Viaggi esplorativi, pieni di carica umana, di cui oggi Jacques Borgetto ne riconosce tutto il valore per l’arricchimento che gli hanno fornito. Le sue collezioni permanenti alla Maison de la Photographie européenne testimoniano il suo percorso d’artista.
ANTONELLA POLI | « Regarder parfois voir », ci dice Jacques Borgetto durante il nostro incontro dell’11 giugno scorso. Parigi é la sua citta. Ma lui é il fotografo dei viaggi, dei paesaggi e degli animali. La fotografia é stata da sempre il suo mestiere come lo stesso autore afferma. Quest’arte gli dà la possibilità di concretizzare in immagini la sua sensibilità verso gli esseri umani, di cogliere le luci e la forza della natura , di scrutare al di là degli sguardi di un semplice cane. Di origine italiana, (suo nonno paterno era piemontese), ha cominciato a viaggiare molto presto per mettere al servizio del suo “occhio” acuto la sua caméra. Fedele alla tecnica tradizionale dell’argentique, oggi Jacques Borgetto si é aperto anche al digitale, senza che il suo stile sia cambiato. L’Argentina, il Cile, il Tibet, il Mali sono state le sue mete importanti che gli hanno permesso di descrivere con un realismo acuto queste parti del mondo lontane dalla sua Francia mettendone in rilievo gli aspetti più nascosti, inconsueti e soprattutto fotogrando e immortalando l’anima delle popolazioni che incontrava sul suo cammino. Viaggi esplorativi, pieni di carica umana, di cui oggi Jacques Borgetto ne riconosce tutto il valore per l’arricchimento che gli hanno fornito. Le sue collezioni permanenti alla Maison de la Photographie européenne testimoniano il suo percorso d’artista. L’elemento umano, che é sempre messo in risalto, le arricchisce donandole l’anima. Sguardi comuni e sorpresi s’incrociano nei bistrot, passionali nei duo di tango, e nei paesaggi in cui la popolazione locale é ritratta nei loro aspetti quotidiani. Prevale il bianco e nero, il colore appare nelle foto scattate nel Delta del Tigre ( questo nome proviene dall’appellazione data dai primi colonizzatori europei ai giaguari del Sud America), zona che fa parte di Buenos Aires e che é situata all’estremità sud del Rio Paranà. In particolare, ne viene ritratta la natura rigogliosa con le sue luci e ombre, le sue costruzioni caratteristiche, come delle palafitte, che ospitano gli indigeni del luogo. Il contrasto appare tra la semplicità di vita degli abitanti del luogo e le tinte forti della vegetazione che risaltano vigorose dappertutto.
L’elemento umano, che é sempre messo in risalto, le arricchisce donandole l’anima. Sguardi comuni e sorpresi s’incrociano nei bistrot, passionali nei duo di tango, e nei paesaggi in cui la popolazione locale é ritratta nei loro aspetti quotidiani. Prevale il bianco e nero, il colore appare nelle foto scattate nel Delta del Tigre ( questo nome proviene dall’appellazione data dai primi colonizzatori europei ai giaguari del Sud America), zona che fa parte di Buenos Aires e che é situata all’estremità sud del Rio Paranà. In particolare, ne viene ritratta la natura rigogliosa con le sue luci e ombre, le sue costruzioni caratteristiche, come delle palafitte, che ospitano gli indigeni del luogo. Il contrasto appare tra la semplicità di vita degli abitanti del luogo e le tinte forti della vegetazione che risaltano vigorose dappertutto. MARAT | Nove e mezza del mattino. Piena notte. Mi svegliano i bassi di uno stereo. E mi accorgo che il vicino sta ascoltando Branduardi. Sì, Branduardi. O tu ciellino sovraeccitato che rompi i coglioni senza neanche un valido motivo… Allora mi alzo e bevo il caffè, che tanto non è cosa. E osservo. Il caseggiato di ringhiera che mi avvolge. In fondo a destra c’è la gabber. Fanciulla delicata di anfibi e bestemmie. Che in un indimenticabile Natale accolse i doni del Signore sparando techno hardcore in cortile. Roba da 180 battiti al minuto. Che ognuno c’ha le sue tradizioni. In fondo a sinistra l’anziano vetraio. Vive sul mio stesso fuso orario. Di notte è al suo tavolo di lavoro, la finestra aperta, gli occhiali sulla punta del naso. È una figura rassicurante, qualcosa tipo “casa”. Sotto invece intravedo la sciura Maria, sul balcone con il ventaglio a rinfrescarsi in mezzo alle cosce. E tutti insieme si sta qui, si sta bene. E mentre mi accendo la prima sigaretta, penso invece a quella strana convivenza del Crt. Il contrappasso del reinventarsi con l’aiuto dei nemici di un tempo: Crt Artificio e Triennale. Che fuoco e fiamme fece per avere indietro il Teatro dell’Arte, scoprire di non sapere cosa farsene e ora ridarlo in gestione alla neonata fondazione dei “Crt”, dall’età media elevata assai. Questa la soluzione trovata da Quaglia, supermanager (e politico) chiamato a risanare un teatro sommerso dai debiti, fioriti sotto la monarchia del Professore. Tanti debiti. Pochi margini d’intervento. Allora, vieni a vivere con me, come cantava Luca Carboni. Che la vita è troppo corta e non possiamo perdere tempo, o forse è proprio il tempo che non può perdere noi. Ma qui non c’è cuore. E mi viene il dubbio che sia questo il gusto amaro che sento in bocca. La scelta è giusta. Forse l’unica. Ma la sensazione di avere di fronte un governo tecnico, mi spiazza. Sano? Sano. Ma in due ore di conferenza, neanche mezza parola di teatro. Teatro vero. Ci saranno dei curatori al posto di un direttore artistico. Uno spazio ancora da rendere agibile a iniezioni di denaro pubblico. Attenzioni ministeriali da conquistare, debiti da pagare, i pochi dipendenti rimasti da assorbire (loro sì, tutto cuore). Insomma, strategie aziendali per i tre nemiciamici. Come Red & Toby. Eppure… Eppure da qualche parte ci devono ancora essere le foto. Di Kantor. Del Living. Della Mnouchkine. Forse in qualche baule.
MARAT | Nove e mezza del mattino. Piena notte. Mi svegliano i bassi di uno stereo. E mi accorgo che il vicino sta ascoltando Branduardi. Sì, Branduardi. O tu ciellino sovraeccitato che rompi i coglioni senza neanche un valido motivo… Allora mi alzo e bevo il caffè, che tanto non è cosa. E osservo. Il caseggiato di ringhiera che mi avvolge. In fondo a destra c’è la gabber. Fanciulla delicata di anfibi e bestemmie. Che in un indimenticabile Natale accolse i doni del Signore sparando techno hardcore in cortile. Roba da 180 battiti al minuto. Che ognuno c’ha le sue tradizioni. In fondo a sinistra l’anziano vetraio. Vive sul mio stesso fuso orario. Di notte è al suo tavolo di lavoro, la finestra aperta, gli occhiali sulla punta del naso. È una figura rassicurante, qualcosa tipo “casa”. Sotto invece intravedo la sciura Maria, sul balcone con il ventaglio a rinfrescarsi in mezzo alle cosce. E tutti insieme si sta qui, si sta bene. E mentre mi accendo la prima sigaretta, penso invece a quella strana convivenza del Crt. Il contrappasso del reinventarsi con l’aiuto dei nemici di un tempo: Crt Artificio e Triennale. Che fuoco e fiamme fece per avere indietro il Teatro dell’Arte, scoprire di non sapere cosa farsene e ora ridarlo in gestione alla neonata fondazione dei “Crt”, dall’età media elevata assai. Questa la soluzione trovata da Quaglia, supermanager (e politico) chiamato a risanare un teatro sommerso dai debiti, fioriti sotto la monarchia del Professore. Tanti debiti. Pochi margini d’intervento. Allora, vieni a vivere con me, come cantava Luca Carboni. Che la vita è troppo corta e non possiamo perdere tempo, o forse è proprio il tempo che non può perdere noi. Ma qui non c’è cuore. E mi viene il dubbio che sia questo il gusto amaro che sento in bocca. La scelta è giusta. Forse l’unica. Ma la sensazione di avere di fronte un governo tecnico, mi spiazza. Sano? Sano. Ma in due ore di conferenza, neanche mezza parola di teatro. Teatro vero. Ci saranno dei curatori al posto di un direttore artistico. Uno spazio ancora da rendere agibile a iniezioni di denaro pubblico. Attenzioni ministeriali da conquistare, debiti da pagare, i pochi dipendenti rimasti da assorbire (loro sì, tutto cuore). Insomma, strategie aziendali per i tre nemiciamici. Come Red & Toby. Eppure… Eppure da qualche parte ci devono ancora essere le foto. Di Kantor. Del Living. Della Mnouchkine. Forse in qualche baule.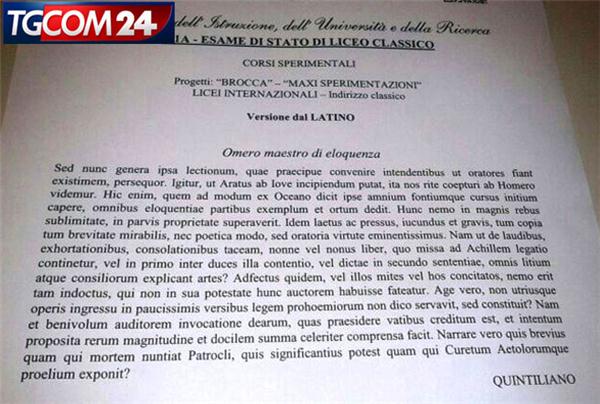 RENZO FRANCABANDERA | “La tua azienda favorisce la mobilità”. Così mi capitava di leggere su un banner nella homepage di una intranet aziendale in questi giorni. Un messaggio a qualche decina di migliaia di dipendenti di un grande gruppo sparsi nel mondo e chiamati a salpare con l’audacia di Ulisse. Verso dove? Da- a? E per quanto tempo? Mi imbarco ma tornerò a casa?
RENZO FRANCABANDERA | “La tua azienda favorisce la mobilità”. Così mi capitava di leggere su un banner nella homepage di una intranet aziendale in questi giorni. Un messaggio a qualche decina di migliaia di dipendenti di un grande gruppo sparsi nel mondo e chiamati a salpare con l’audacia di Ulisse. Verso dove? Da- a? E per quanto tempo? Mi imbarco ma tornerò a casa?


 GIULIA MURONI | Un corpo, sovraesposto e dissezionato nelle proiezioni, in penombra. Un corpo silenzioso, che non produce narrazione.
GIULIA MURONI | Un corpo, sovraesposto e dissezionato nelle proiezioni, in penombra. Un corpo silenzioso, che non produce narrazione. RENZO FRANCABANDERA | “Come capire Burri? Eh, è una parola!”
RENZO FRANCABANDERA | “Come capire Burri? Eh, è una parola!”