 MARIO DI CALO |. Nella bella rassegna “Trend/Nuove Frontiere Della Scena Britannica”, arrivata alla dodicesima edizione, a cura di Rodolfo Di Gianmarco presso la storica sala romana Teatro Belli, sono stati portati in scena due ‘pezzi’ del professore, attore ed autore Tim Crouch: Banquo e Peaseblossom, tratti dal ciclo dei monologhi “I, Shakespeare”, tradotti per la scena da Pieraldo Girotto e con la appassionata ed intensa regia di Fabrizio Arcuri.
MARIO DI CALO |. Nella bella rassegna “Trend/Nuove Frontiere Della Scena Britannica”, arrivata alla dodicesima edizione, a cura di Rodolfo Di Gianmarco presso la storica sala romana Teatro Belli, sono stati portati in scena due ‘pezzi’ del professore, attore ed autore Tim Crouch: Banquo e Peaseblossom, tratti dal ciclo dei monologhi “I, Shakespeare”, tradotti per la scena da Pieraldo Girotto e con la appassionata ed intensa regia di Fabrizio Arcuri.
A sipario aperto con tre neon bianchi sospesi nell’aria, che poi saranno quasi esclusivamente la fonte di illuminazione della serata, su un fondale di stelle filanti argentate si rifrangono le luci mentre due banconi bianchi di diversa grandezza servono rispettivamente come banco regia e l’altro, di volta in volta, come letto, bara, trono, podio per il protagonista.
Mentre il pubblico ancora si accomoda in sala, entra Enrico Campanati/Banquo – di bianco vestito e con un bicchiere di whisky in mano – che con una specie di gramelot cerca le parole giuste per poter riferire la sua versione dei fatti, ma lui è morto e gli spettatori sono vivi, a lui è capitato di morire, non a loro, e infatti incita e invita il pubblico con un: “Prova ad immaginare…”. Prova a tirare tutti dentro la sua vicenda, ed ogni spettatore diventa, di volta in volta, il conte di Glamis, Duncan, Macduff, insomma tutti i personaggi, inclusi i servi, della straordinaria storia che racconta.
Fleance suo figlio è impersonato da Matteo Selis, che armato di chitarra elettrica, interferisce con appropriate incursioni musicali nel monologo paterno, ma è all’occorrenza anche datore luci e/o commentatore dell’azione.
La storia che racconta Banquo è quella di Macbeth, giustamente proposta da un osservatore che non è più osservatore poiché spettro. Comunque siano andate le cose può solo raccontarle: la storia non si modifica, la si racconta e basta, con quanta più obiettività è possibile, ed è quanto fa Tim Crouch.
L’immaginazione serve solo a far comprendere meglio i fatti ma non modifica la realtà.
Enrico Campanati, con toni quasi cabarettistici, narra con afflato e giusto risentimento quanto accaduto. Pur usando a profusione sangue coagulato che attinge da varie botole situate ad arte sulla scena non risulta mai tragico, al contrario, come se il suo stato di ombra/spettro gli permettesse il giusto distacco dalle cose.
Sullo stesso impianto di rilettura del classico del Bardo è anche Peaseblossom, commissionato a Tim Crouch nel 2004 per il festival di Brighton: racconta dei fatti accaduti durante una famosa notte di mezza estate in una Atene immaginifica ed immaginaria, riportati stavolta diligentemente dal candore di un folletto dal nome di Fiordipisello, interpretato qui dal comunicativo Matteo Angius.
Una proiezione sul fondo del palcoscenico nudo avverte, all’inizio, che si tratta un primo studio/lettura ma appare a tutti gli effetti – e lo è – uno spettacolo compiuto ed anche ben riuscito, suddiviso in sei sogni: Il calabrone, Nudo, La Recita, Il Fiore, Pruriginoso Pruriginoso e La Morte.
In un contesto da
post-festino, un naturalissimo Matteo Angius, con leggerezza ed autenticità, inforcando occhiali e qualche volta con il copione in mano, coinvolge il pubblico nello stesso gioco dell’altro spettacolo.
Lo spettatore, con l’uso di una maschera sopra-titolata, diventa ogni volta un personaggio diverso della storia, che il buon Fiordipisello con dovizia di particolari fa rivivere durante tutto lo spazio della notte, prima che sopraggiunga l’alba e non possa più sognare.
Con lui in scena stavolta c’è il regista Fabrizio Arcuri, che al banco di regia, accarezza con il suo sguardo sornione il suo attore, approntando spesso la scena con trovate illuminanti, come il carillon con i personaggi sospesi ad una cordicella, che diventano la commedia che inscenano gli artigiani ateniesi o quando, durante il matrimonio dei giovani sposi, accompagnati dalla celeberrima musica di Felix Mendelssohn, lancia riso a profusione.
Fabrizio Arcuri ‘scrive’ la sua regia in perfetto accordo con l’autore e racconta dei fatti accaduti assecondando e imprimendo leggerezza alle due famose storie Shakespeariane: scrive come se si trattasse di vere e proprie pagine, e se si tratta di Banquo del Macbeth utilizza il bianco dove il rosso sangue degli eccidi meglio risalti e meglio possa essere un monito per le generazioni future a non ripetere gli stessi errori; se invece si tratta di Fiordipisello del Sogno di una notte di mezza estate, aiuta e sostiene lo svolgersi della vicenda con proiezioni che conducono per mano durante tutta la durata della notte.
Sembra vivere uno stato di grazia nella duplice semplicità e freschezza di queste due nitide serate di apprezzabile teatro.
Qui un video di Maria Elena Buslacchi con un’intervista ad Arcuri. Provate a immaginare…
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=THE0nNebAho]

 RENZO FRANCABANDERA | Le fumatrici di pecore della compagnia Abbondanza/Bertoni aveva debuttato a Castiglioncello l’estate passata, quale esito di un percorso di crescita e confronto fra Antonella Bertoni e Patrizia Birolo.
RENZO FRANCABANDERA | Le fumatrici di pecore della compagnia Abbondanza/Bertoni aveva debuttato a Castiglioncello l’estate passata, quale esito di un percorso di crescita e confronto fra Antonella Bertoni e Patrizia Birolo. VINCENZO SARDELLI | Che differenza c’è tra non dichiarare la verità e mentire? Tra l’accontentarsi di pubbliche verità e l’adagiarsi su private menzogne? È questo l’input da cui parte “Tricher 3_Non dire falsa testimonianza”, spettacolo selezionato per il Napoli Fringe Festival 2013, che i torinesi di Mo.Lem (Movimento Libere Espressioni Metropolitane) hanno portato in scena a Zona K a Milano.
VINCENZO SARDELLI | Che differenza c’è tra non dichiarare la verità e mentire? Tra l’accontentarsi di pubbliche verità e l’adagiarsi su private menzogne? È questo l’input da cui parte “Tricher 3_Non dire falsa testimonianza”, spettacolo selezionato per il Napoli Fringe Festival 2013, che i torinesi di Mo.Lem (Movimento Libere Espressioni Metropolitane) hanno portato in scena a Zona K a Milano. MARAT | A un certo punto Andre Agassi non vince più. Ha perso entusiasmo lo scugnizzo di Las Vegas. La risposta supera l’incrocio delle linee, il rovescio a due mani finisce in rete. Questione di vizi, donne sbagliate, manager che han rotto le balle e quel concetto che racchiude un mondo: nessuna gioia per una vittoria è pari al dolore per una sconfitta. Insomma, il guappo col parrucchino ha un che di esistenzialista. Così molla tutto e ricomincia dai tornei universitari. E risorge. Comunque Agassi mi è venuto in mente pensando alle recenti chiacchierate sullo stato dell’arte. Dove a raccontare del mondo del teatro c’erano i soliti amici: vecchi assessori, nuovi assessori, vecchi direttori di stabili (di quelli non ce ne sono di nuovi), vecchi professori universitari (idem), rivoluzionari istituzionalizzati. Radical-chic inchiodati alle poltrone, nel curioso ruolo di dar voce a problematiche popolari. Già. Oppure grillini teatrali de noantri, che ancora non si capisce bene come possano unire le istanze dei Lavoratori dell’Arte con la gestione da ragazzini di un qualsiasi centro sociale. Retoriche varie, slogan di più di mezzo secolo fa, velleità post-sessantottine. E io che pensavo ad Andre Agassi. Non so perché, come diceva Raz Degan. Forse sono fatti miei… O forse perché mi saliva quel bisogno di un passetto indietro, di respirare con più agio. Di sentirsi assumere parte della responsabilità delle cose, che non è che cada tutto maledettamente dall’alto. Un passetto indietro magari a fianco di impiegati e tecnici, quelli che non parlano mai. Oppure a fianco di chi fa i salti mortali per pagare tasse e contributi, mettere lo spazio a norma, trovare finanziamenti senza taroccar le carte. Un passetto indietro per fermarsi e ricominciare. Invece no, la solita logorrea di giacobini in camicia botton down. Anche se bisogna ammettere che si vestono meglio. Perché diciamolo una volta per tutte: i pantaloni nepalesi non faranno mai bene a nessun tipo di causa. Manco a quella dei nepalesi.
MARAT | A un certo punto Andre Agassi non vince più. Ha perso entusiasmo lo scugnizzo di Las Vegas. La risposta supera l’incrocio delle linee, il rovescio a due mani finisce in rete. Questione di vizi, donne sbagliate, manager che han rotto le balle e quel concetto che racchiude un mondo: nessuna gioia per una vittoria è pari al dolore per una sconfitta. Insomma, il guappo col parrucchino ha un che di esistenzialista. Così molla tutto e ricomincia dai tornei universitari. E risorge. Comunque Agassi mi è venuto in mente pensando alle recenti chiacchierate sullo stato dell’arte. Dove a raccontare del mondo del teatro c’erano i soliti amici: vecchi assessori, nuovi assessori, vecchi direttori di stabili (di quelli non ce ne sono di nuovi), vecchi professori universitari (idem), rivoluzionari istituzionalizzati. Radical-chic inchiodati alle poltrone, nel curioso ruolo di dar voce a problematiche popolari. Già. Oppure grillini teatrali de noantri, che ancora non si capisce bene come possano unire le istanze dei Lavoratori dell’Arte con la gestione da ragazzini di un qualsiasi centro sociale. Retoriche varie, slogan di più di mezzo secolo fa, velleità post-sessantottine. E io che pensavo ad Andre Agassi. Non so perché, come diceva Raz Degan. Forse sono fatti miei… O forse perché mi saliva quel bisogno di un passetto indietro, di respirare con più agio. Di sentirsi assumere parte della responsabilità delle cose, che non è che cada tutto maledettamente dall’alto. Un passetto indietro magari a fianco di impiegati e tecnici, quelli che non parlano mai. Oppure a fianco di chi fa i salti mortali per pagare tasse e contributi, mettere lo spazio a norma, trovare finanziamenti senza taroccar le carte. Un passetto indietro per fermarsi e ricominciare. Invece no, la solita logorrea di giacobini in camicia botton down. Anche se bisogna ammettere che si vestono meglio. Perché diciamolo una volta per tutte: i pantaloni nepalesi non faranno mai bene a nessun tipo di causa. Manco a quella dei nepalesi. ELENA SCOLARI | Oibò sono morto è il bel titolo dello spettacolo prodotto dalla Compagnia Donati/Olesen per I Teatri del Sacro di cinque anni fa, con Jacob Olesen e Giovanna Mori, autori e registi del lavoro. Ci troviamo per vederlo al PalaBachelet di Oggiono – Lecco, uno degli spazi utilizzati per la rassegna provinciale Circuiti Teatrali. Citiamo il luogo di rappresentazione perché tutti gli spettatori presenti lo ricorderanno come un luogo “allarmante”…: lo svolgimento è infatti stato bruscamente interrotto dall’antifurto, partito a sorpresa e rimasto ostinatamente inarrestabile per alcuni minuti, vogliamo per questo attribuire una lode particolare ai due interpreti che, lontanissimi da alcune bizzose star del mondo teatrale, hanno professionalmente sospeso e poi ripreso lo spettacolo per portarlo a termine, offrendo un importante esempio di serietà e rispetto per il pubblico.
ELENA SCOLARI | Oibò sono morto è il bel titolo dello spettacolo prodotto dalla Compagnia Donati/Olesen per I Teatri del Sacro di cinque anni fa, con Jacob Olesen e Giovanna Mori, autori e registi del lavoro. Ci troviamo per vederlo al PalaBachelet di Oggiono – Lecco, uno degli spazi utilizzati per la rassegna provinciale Circuiti Teatrali. Citiamo il luogo di rappresentazione perché tutti gli spettatori presenti lo ricorderanno come un luogo “allarmante”…: lo svolgimento è infatti stato bruscamente interrotto dall’antifurto, partito a sorpresa e rimasto ostinatamente inarrestabile per alcuni minuti, vogliamo per questo attribuire una lode particolare ai due interpreti che, lontanissimi da alcune bizzose star del mondo teatrale, hanno professionalmente sospeso e poi ripreso lo spettacolo per portarlo a termine, offrendo un importante esempio di serietà e rispetto per il pubblico. ANTONELLA POLI | Si tratta di una prima per Emanuel Gat al Théâtre de la Ville, un appuntamento importante di fronte al pubblico esigente del teatro parigino, tempio della danza contemporanea.
ANTONELLA POLI | Si tratta di una prima per Emanuel Gat al Théâtre de la Ville, un appuntamento importante di fronte al pubblico esigente del teatro parigino, tempio della danza contemporanea.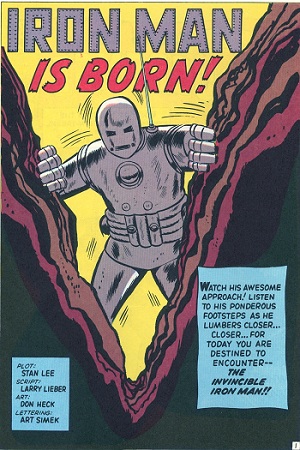

 GINA GUANDALINI | A Londra l’offerta più ghiotta resta sempre quella teatrale. Tra musical, prosa, tragedia, avanguardia, non passa una settimana che non ci sia una “prima” di qualche interesse, con pubblico sempre al completo, competente ed entusiasta.
GINA GUANDALINI | A Londra l’offerta più ghiotta resta sempre quella teatrale. Tra musical, prosa, tragedia, avanguardia, non passa una settimana che non ci sia una “prima” di qualche interesse, con pubblico sempre al completo, competente ed entusiasta. LAURA NOVELLI | Una donna come tante. Una vita come tante. Trascorsa a Cracovia tra gli anni Venti del ‘900 e il 2000. Un marito internato in un campo di concentramento e liberato alla fine della seconda guerra. Due figli. Un matrimonio dissoltosi con un abbandono. Solitudine. E un segreto così intimo e sorprendente da essere stato carpito solo dopo la morte: per ben 57 anni Janina Turek – questo il nome della donna – ha meticolosamente annotato su 758 taccuini divisi per argomento i “dati” della sua vita. Sarebbe a dire: colazioni, pranzi e cene, regali ricevuti e regali fatti, visite ricevute e visite fatte, spettacoli teatrali visti, telefonate, programmi televisivi, incontri fortuiti, appuntamenti fissati. Migliaia di annotazioni che ricostruiscono, con geometrica precisione, il suo rapporto con la realtà, con la nuda e cruda concretezza del quotidiano, così come esso si è sviluppato nel corso di un’intera esistenza.
LAURA NOVELLI | Una donna come tante. Una vita come tante. Trascorsa a Cracovia tra gli anni Venti del ‘900 e il 2000. Un marito internato in un campo di concentramento e liberato alla fine della seconda guerra. Due figli. Un matrimonio dissoltosi con un abbandono. Solitudine. E un segreto così intimo e sorprendente da essere stato carpito solo dopo la morte: per ben 57 anni Janina Turek – questo il nome della donna – ha meticolosamente annotato su 758 taccuini divisi per argomento i “dati” della sua vita. Sarebbe a dire: colazioni, pranzi e cene, regali ricevuti e regali fatti, visite ricevute e visite fatte, spettacoli teatrali visti, telefonate, programmi televisivi, incontri fortuiti, appuntamenti fissati. Migliaia di annotazioni che ricostruiscono, con geometrica precisione, il suo rapporto con la realtà, con la nuda e cruda concretezza del quotidiano, così come esso si è sviluppato nel corso di un’intera esistenza. BRUNA MONACO | Nel luglio del 2011, in occasione della presentazione di
BRUNA MONACO | Nel luglio del 2011, in occasione della presentazione di