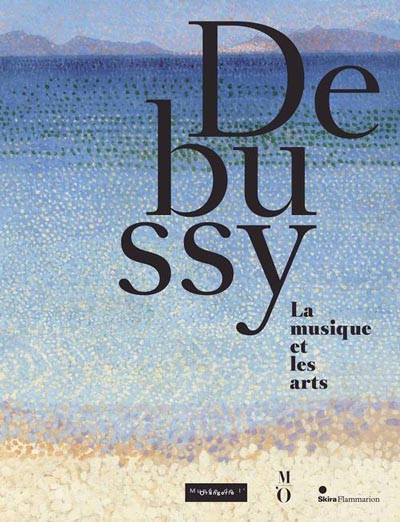 MARIA CRISTINA SERRA | La musicalità infinita delle iridescenti Ninfee di Monet, pregne di luce riflessa nella superficie a specchio degli stagni, è lo sfondo sublime nel quale immergersi, accompagnati dalla fluidità delle note di Claude Debussy. Un viaggio attraverso una rassegna che ci svela l’intreccio fra percezione visiva e uditiva, in un’unica trama, senza confini di luoghi e di tempi, allestita al Musée de L’Orangerie (fino al 16 Giugno).
MARIA CRISTINA SERRA | La musicalità infinita delle iridescenti Ninfee di Monet, pregne di luce riflessa nella superficie a specchio degli stagni, è lo sfondo sublime nel quale immergersi, accompagnati dalla fluidità delle note di Claude Debussy. Un viaggio attraverso una rassegna che ci svela l’intreccio fra percezione visiva e uditiva, in un’unica trama, senza confini di luoghi e di tempi, allestita al Musée de L’Orangerie (fino al 16 Giugno).
Per il 150° anniversario della nascita del “più francese” dei compositori, la mostra “Debussy, la musica e le arti”, curata in maniera strutturalista da Guy Cogeval, Jean-Michel Nectoux e Xavier Rey, restituisce il complesso itinerario artistico del grande musicista, legandolo a quello dei numerosi esponenti dell’arte con cui venne in contatto. Si è, inoltre, ricreata l’atmosfera estetica di un’epoca nella quale si respirava l’aria di transizione fra lo stato d’animo impressionista e quello simbolista, la fascinazione dell’Art Nouveau e l’amore per l’Oriente e il Giapponesismo: scenario sfaccettato in cui si libera l‘immaginario del musicista innovatore del ‘900.
Una rassegna di grande seduzione che accosta (in un ambiente tinteggiato di blu profondo e illuminato da luci sapienti e soffuse, in contrasto con la luminosità del Museo) affinità e discordanze, arte e letteratura, accompagnate dal sottofondo melodico di un “sogno a cui sono stati tolti i veli”, inseguito per tutta la vita da Debussy, pervaso dal desiderio di catturare un presente inafferrabile.
Il percorso, attraverso un andamento ad arabesque, è segnato dalle opere di Monet, Manet, Degas, Renoir, Turner, Denis, Bonnard, Redon , Rossetti, Moreau, Klimt, Munch, Gauguin, Hokusai, Whistler, Kandisky; dalle sculture di Camille Claudel che riusciva a trasformare in materia l’anima; dai contributi letterari di Mallarmé, Villon, Valéry,
E. A. Poe e Baudelaire; dalle coreografie del ballerino Nijinsky, che aveva rubato agli uccelli il segreto della leggerezza. Il tutto intervallato con un’alchimia perfetta fra immagini e suoni, con documenti, oggetti, suppellettili, carteggi, spartiti e foto d’epoca, preziosi per ricreare lo scenario storico della Bell’Epoque.
E’un rapporto empatico quello che Debussy stringe con la natura, liberandola dalla staticità delle forme, innalzandola a principio ispiratore, intuendo “la possibilità di una musica costruita appositamente per l’aria aperta, fatta tutta di grandi linee, di audacia vocale e strumentale, che gioca nell’aria libera e plana gioiosamente sulle cime degli alberi”.
Il linguaggio del vento e dell’acqua è colto nelle sue misteriose analogie con le asimmetrie della struttura musicale, rivelando e nascondendo assonanze e dissonanze armoniche, cariche di ovattate sonorità senza regole prestabilite. “Gli accordi devono essere incompleti, fluttuanti, in modo che, sfumando, il tono possa sempre finire dove si vuole, uscire e rientrare dalla parte che si percepisce”, diceva il musicista. E’ nella libertà che la disciplina deve costruire le sue fondamenta, ”sforzandosi”, spiegava Debussy, “di conservare ad ogni timbro la sua purezza, di metterlo al suo vero posto”.
“Dialogue du vent et de la mer”, “Le jet d’eau, “Refletts dans l’eau”, “La mer”, “L’après-midi d’un faune”, suggestivi titoli di alcune sue composizioni, sono la chiave di lettura per penetrare nei tanti mondi sommersi, o in quelli luminosi, al pari delle vetrate delle cattedrali gotiche, e che fanno da eco alle suggestioni evocate dai dipinti in mostra. L’intensità e le molteplici sensazioni, evocate dal mare, sono raffigurate dalle leggere pennellate di Monet, intonate sulle sfumature di bianchi velati di grigio-azzurri e rosa, sotto le cui trasparenze emergono gli spezzoni brunastri delle rocce.
La ”Marina” quieta di Degas scopre un infinito mare immobile: solo un filo netto di azzurro separa il cielo punteggiato di nuvole. La “Baia nascosta tra le dune”, dipinta da Turner nel 1845, avvolta dall’abbagliante luce solare che mischia le forme con dorate evanescenze, scopre grovigli di arbusti che si allungano indistinti, fondendosi con la luce dell’orizzonte.
I colori impastati di luminosità sollecitano Debussy ad allontanarsi dalla scrittura musicale classica, per modellare un nuovo linguaggio secondo un ordine cromatico. L’esotismo e l’audacia di Hokusai gli suggeriscono turbamenti improvvisi come “L’Onda” che si innalza brutale verso il cielo calmo: l’eterna contrapposizione fra lo Yin e lo Yang. Il fragore è riassorbito dal silenzio, dalle pause, dagli accordi slegati, sussurrati. Il “non detto” è cercato da Debussy come “mezzo di espressione per far volare l’emozione di una frase “.
L’impalpabile indefinito che si fa finito nella zona di mezzo fra notte e giorno di Redon, mentre intinge il suo pennello nei colori del silenzio, è speculare ai preludi per pianoforte. La “Notte stellare” di Munch dalle forme incerte, dinamiche, visionarie, si specchia nella scomposizione stilistica di alcuni suoi brani. La “Sala della musica” di Vuillard, satura di colori e di elementi sovrapposti, è una metafora della fluidità melodica nel tessuto orchestrale. Il notturno danzante di H. Winslow della “Notte d’estate” ci lascia una sensazione di vertigine, come se onde sonore riempissero la notte. La bellissima “Marina con vacca” di Gauguin, priva di valori spaziali e ricca di
tinte forti, evoca interruzioni improvvise di armonie, ricomposte in una stesura musicale dalle infinite variazioni. E’ una sinfonia in verde e rosa quella evocata dai “Roseti sotto gli alberi”di Klimt. “Il più ricco insegnamento viene dalla musica”, scriveva Kandisky nel suo saggio “Lo spirituale nell’arte”: “nasce da qui l’attuale ricerca di un ritmo pittorico, di una costruzione matematica astratta; il valore che si da alla ripetizione della tonalità cromatica, al dinamismo dei colori”, che nel “Parco di Saint-Cloud” si diffondono con idilliaca grazia, contrastati ma fluidamente legati tra loro. “Le spiagge dorate” di H. E. Cross, che penetrano in un crescendo di riflessi rosati nel mare di un sereno azzurro, si dischiudono alle sensazioni oniriche, come trasportate dalle note de “La mer”. Al centro di una parete divisoria, fra due ali di capolavori, l’enigmatica “Fanciulla eletta” di G. Rossetti, dallo ieratico erotismo, giocato sui cromatismi degli ocra e dei neri, irradiati di bianco, rimanda al poema lirico che alla fine dell’Ottocento rivelò il temperamento di Debussy. Come l’intermittenza del cuore, di una “Sérénade interrompue”, che lascia sospesi i sentimenti, per decrescere improvvisamente, “La Valse” di Camille Claudel, che nel bronzo insieme ai corpi avviluppati fondeva il suo genio artistico, il vortice della passione disperata per Rodin, il dolore per una “pazzia indotta”, ci appaiono come l’allegoria di un’epoca dorata sotto la quale covavano le contraddizioni di una società, che si stava avviando inesorabilmente verso la catastrofe della Prima guerra mondiale.
Un contributo in francese sulla mostra
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=bgJVsAUqMjc]
La musica di Debussy
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=xbsX74pFr9I]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqAJ3fUaCpU]

 RENZO FRANCABANDERA | La ripresa dell’Hamlet di Lenz Rifrazioni è a suo modo un evento. Dopo gli allestimenti alla Rocca dei Rossi di San Secondo (2010) e alla Reggia di Colorno (2011), Lenz ha riproposto la sua rilettura del classico di Shakespeare diretta da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, nell’ultima settimana di maggio all’interno della stupenda cornice del Teatro Farnese di Parma. Con cadenza annuale, dunque, questo itinerario esperienziale porta gli spettatori all’interno di un percorso-confronto con l’altro da sé e con il sé fragile che con più difficoltà accettiamo. Il cuore di questo lavoro, persino della stesura drammaturgica e della più profonda intimità che l’allestimento emana, è dovuto alla partecipazione, in qualità di attori, di alcuni degli ospiti della Comunità Terapeutico Riabilitativa, per un’esperienza iniziata oltre dieci anni fa in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Parma.
RENZO FRANCABANDERA | La ripresa dell’Hamlet di Lenz Rifrazioni è a suo modo un evento. Dopo gli allestimenti alla Rocca dei Rossi di San Secondo (2010) e alla Reggia di Colorno (2011), Lenz ha riproposto la sua rilettura del classico di Shakespeare diretta da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, nell’ultima settimana di maggio all’interno della stupenda cornice del Teatro Farnese di Parma. Con cadenza annuale, dunque, questo itinerario esperienziale porta gli spettatori all’interno di un percorso-confronto con l’altro da sé e con il sé fragile che con più difficoltà accettiamo. Il cuore di questo lavoro, persino della stesura drammaturgica e della più profonda intimità che l’allestimento emana, è dovuto alla partecipazione, in qualità di attori, di alcuni degli ospiti della Comunità Terapeutico Riabilitativa, per un’esperienza iniziata oltre dieci anni fa in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Parma.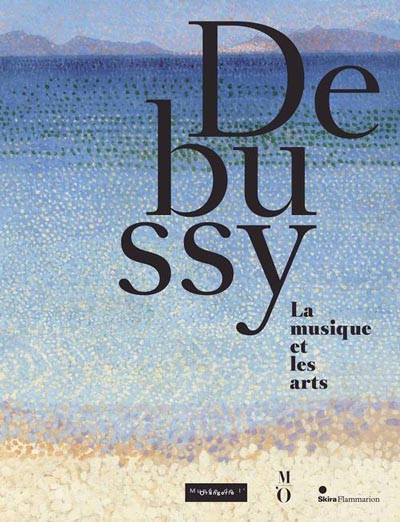 MARIA CRISTINA SERRA | La musicalità infinita delle iridescenti Ninfee di Monet, pregne di luce riflessa nella superficie a specchio degli stagni, è lo sfondo sublime nel quale immergersi, accompagnati dalla fluidità delle note di Claude Debussy. Un viaggio attraverso una rassegna che ci svela l’intreccio fra percezione visiva e uditiva, in un’unica trama, senza confini di luoghi e di tempi, allestita al Musée de L’Orangerie (fino al 16 Giugno).
MARIA CRISTINA SERRA | La musicalità infinita delle iridescenti Ninfee di Monet, pregne di luce riflessa nella superficie a specchio degli stagni, è lo sfondo sublime nel quale immergersi, accompagnati dalla fluidità delle note di Claude Debussy. Un viaggio attraverso una rassegna che ci svela l’intreccio fra percezione visiva e uditiva, in un’unica trama, senza confini di luoghi e di tempi, allestita al Musée de L’Orangerie (fino al 16 Giugno).
 RENZO FRANCABANDERA | Nelle primissime pagine dei più celebri e divulgati manuali su come si costruiscono le drammaturgie, il primo elemento cui si fa cenno è la costruzione di un conflitto. “Red”, Rosso, di John Logan portato in scena per la prima volta in Italia è una drammaturgia costruita attorno al conflitto fra il pittore Mark Rothko, in questo caso disegnato con una personalità egocentrica e misantropa ai limiti dello psicotico, e un giovane apprendista, che in realtà fa esplodere con la sua paziente vicinanza al maestro, i suoi conflitti interiori, frutto del rancore verso una società, quella americana di fine anni 50 e inizio 60, che ancora non ne apprezza appieno il valore artistico, preferendo alle sue tele di natura informale più orientate al cromatismo la forza del gesto di Pollock, che aveva sfidato e trovato la morte nel 1956.
RENZO FRANCABANDERA | Nelle primissime pagine dei più celebri e divulgati manuali su come si costruiscono le drammaturgie, il primo elemento cui si fa cenno è la costruzione di un conflitto. “Red”, Rosso, di John Logan portato in scena per la prima volta in Italia è una drammaturgia costruita attorno al conflitto fra il pittore Mark Rothko, in questo caso disegnato con una personalità egocentrica e misantropa ai limiti dello psicotico, e un giovane apprendista, che in realtà fa esplodere con la sua paziente vicinanza al maestro, i suoi conflitti interiori, frutto del rancore verso una società, quella americana di fine anni 50 e inizio 60, che ancora non ne apprezza appieno il valore artistico, preferendo alle sue tele di natura informale più orientate al cromatismo la forza del gesto di Pollock, che aveva sfidato e trovato la morte nel 1956.