RENZO FRANCABANDERA | In tempi di sperimentazioni, ma meno estreme, con la crisi che morde e la gente in cerca di certezze, torna forte il fascino del teatro di tradizione, quello che in trent’anni è cambiato senza cambiare.
 Devo dire di avere una personale attenzione e simpatia per le regie di Ugo Chiti e il lavoro che sempre con puntualità L’Arca Azzurra Teatro porta a compimento senza sbraitanti clamori. Eppure un po’ di spocchia potrebbero permettersela, alle soglie proprio dei trent’anni che ricorreranno nel 2013, da quel famoso laboratorio che Chiti condusse con gli allora ragazzi del gruppo. Di lì in avanti, lui ha continuato ad essere il punto di riferimento registico della compagnia, di cui ha firmato tutti gli spettacoli e loro il braccio armato di un modo di fare scena pulito, senza fronzoli, attento a quel voler far teatro in lingua toscana che era uno dei postulati di partenza, sfruttando appieno l’enorme comunicativa sonora e gestuale della lingua regionale, ma superando derive folclorico-vernacolari da casa del popolo.
Devo dire di avere una personale attenzione e simpatia per le regie di Ugo Chiti e il lavoro che sempre con puntualità L’Arca Azzurra Teatro porta a compimento senza sbraitanti clamori. Eppure un po’ di spocchia potrebbero permettersela, alle soglie proprio dei trent’anni che ricorreranno nel 2013, da quel famoso laboratorio che Chiti condusse con gli allora ragazzi del gruppo. Di lì in avanti, lui ha continuato ad essere il punto di riferimento registico della compagnia, di cui ha firmato tutti gli spettacoli e loro il braccio armato di un modo di fare scena pulito, senza fronzoli, attento a quel voler far teatro in lingua toscana che era uno dei postulati di partenza, sfruttando appieno l’enorme comunicativa sonora e gestuale della lingua regionale, ma superando derive folclorico-vernacolari da casa del popolo.
E’ così che sono nati sia spettacoli attenti all’evolversi del territorio, come “Allegretto (perbene… ma non troppo)”, “La provincia di Jimmy” e “Paesaggio con figure”, sia spettacoli tratti da drammaturgie della Toscana classica e letteraria. “Ci sono appuntamenti che si possono rimandare a lungo, che si può per anni far finta di non dover onorare, ma arriva prima o poi il momento che quell’incontro diventa irrinunciabile e ti si presenta con l’urgenza che merita, come una necessità, un passo irrimandabile.” E’ con queste parole che loro stessi, Chiti e l’Arca Azzurra, raccontano di questa produzione di tre anni fa che continua tanquillamente a replicare e che abbiamo visto qualche giorno fa a Bergamo, ad inaugurare la stagione Altri Percorsi del Teatro Donizetti. Questa è la Mandragola di Niccolò Machiavelli per l’Arca Azzurra, un incontro che si sapeva di non poter eludere eppure sempre rimandato, sempre spostato più in là nel tempo, finché appena doppiata la boa dei venticinque anni di attività, ecco la compagnia alle prese con la “Commedia perfetta”.
Il piccolo intervento sulle parti più descrittive nel senso della scorrevolezza, aiuta lo spettacolo ad avere un ritmo interno ben ponderato sulle spalle degli interpreti, Giuliana Colzi (autrice anche dei costumi di scena di gran pregio), Andrea Costagli, Dimitri Frosali (impeccabile il suo Nicia tronfio e ignorante allo stesso tempo), e i puntuali Massimo Salvianti, Lucia Socci, Lorenzo Carmagnini, Giulia Rupi e Paolo Ciotti. La scena ha una pedana centrale e attraverso il ricorso ad una decina di piccoli cubi e pochi bastoni che fungono di tempo in tempo da pedane, rialzi, oggetti di altra natura, gli attori riescono a creare ambienti, case, conventi, partizioni delle dinamiche di gruppo, con un allestimento giocoso e canzonatorio che non può non ricordare il Decamerone prodotto l’anno prima.
In onestà, più di tutto restano nella mente proprio la regia e la pulizia dell’allestimento e la prova d’attore di Frosali, che pare veramente perfetto nel personaggio. Il Donizetti è andato tutto esaurito, con un pubblico che ha risposto talmente entusiasta e numeroso, che la direzione artistica forse si è mangiata un po’ le mani per non aver previsto una seconda data. Moltissimi giovani, anche studenti, a far considerare come a volte il tradizionale possa tranquillamente ancora riempire grandi teatri senza problemi, restituendo la sensazione di aver visto un buon lavoro, creativo, equilibrato, corale, che lasciava allo spettatore il giusto margine di fantasia col quale completare l’invisibile di scena.
******************
Cabaret emotivo, per la regia della giovane artista sarda Laura Pazzola, autrice anche della drammaturgia insieme a Luca Rastello, è un lavoro di gruppo costruito in occasione di un bando di concorso per giovani creatività, promosso dallo Stabile della Sardegna. Insieme alla Pazzola in scena c’è un energico gruppo di attori, musicisti, costumisti e tecnici, di fatto forse alla prima prova di navigazione in mare aperto con uno spettacolo pensto e realizzato “in house”, eccezion fatta per il contributo alla drammaturgia di Luca Rastello, giornalista a Repubblica, redattore e poi direttore de L’Indice dei Libri del Mese, Narcomafie e L’Indice.
Lo spettacolo è un cabaret à la Lecoq, dove i giovanissimi interpreti fanno incontrare il pubblico con un giovane guru e motivatore di dinamiche interpersonali e studioso di comportamenti e gesti, Bob (Robert Kelly). E’ questo conferenziere dal tratto sicuro e aitante che, con il supporto di quattro giovani “dottoresse” (Virginie Maillard, Hélène Morzuch, la stessa Laura Pazzola ed Elisabetta Spaggiari) ci mostra non il “perchè ma il come” delle nostre ossessioni quotidiane, delle dipendenze, e quali possono essere le determinanti per il loro superamento.
La logica narrativa è quella dello sketch, attraverso il cui ripetersi, il gruppo può raccontare un’umanità varia e fragile, dove ciascuno diventa portatore sano di ansie e logiche comportamentali che il nostro guru ci aiuterà a decifrare: dall’interpretazione dei gesti e del non verbale, fino all’analisi delle comunicazioni in contesti plurali, lo spettacolo oscilla, con sufficiente equilibrio, fra la lezione e il cabaret, fornendo spunti di interesse. Come nella miglior tradizione del Teatro del gesto del grande maestro francese della cui scuola molti fra gli attori sono allievi, lo spettacolo parte proprio da quel percepire le leggi che organizzano la vita, a partire dall’osservazione del quotidiano, di cui Lecoq fu fra i massimi fautori nella dinamica pedagogica.
Partendo dal movimento e dal gesto, il gruppo ha lavorato con un marchio di fabbrica inconfondibile attorno ad un’idea forse non pariteticamente sviluppata nella componente drammaturgica. Non c’è pretesa di spiegare motivazioni profonde dei comportamenti, c’è una divertita tassonomia di alcune forme di dipendenza, da quella dell’esercizio fisico a quella emotiva giusto per citarne alcune, eppure alla fine ci resta la sensazione che non si sia arrivati davvero da qualche parte, lasciando che a farsi spazio sia soprattutto il metodo recitativo, che a volte più che il mezzo diventa un po’ il fine, a cui la parola è asservita. Anche se nella logica della lezione sui comportamenti gli sketch sono vere e proprie sequenze a scopo didattico e didascalico, le sequenze sembrano un po’ ingenue e così l’impianto narrativo generale soffre di una mancanza di punto di fuoco, quella sorta di orizzonte del pensiero a cui lo spettacolo dovrebbe tendere, e quindi come tutto quello che veleggia senza un direzione univoca, finisce per sembrare lungo.
Come in tutti i cabaret che si rispettino non manca la musica, che è non solo ben pensata, ma finisce per diventare una delle colonne portanti dello spettacolo, quella su cui non occorre metter mani per modifiche di sorta: i tre musicisti sono jazzisti di buon livello, che sorreggono in più punti l’andamento del recitato, facendo non solo da cotrappunto ma non di rado da traino e da tappeto ironico.
Da registrare il rapporto con lo spazio e in generale l’allestimento dal punto di vista scenico, che vuole sembrare povero ma non rinuncia del tutto a qualche vezzo che alla fine risulta superfluo, come l’impalcatura che funge da macchina scenica la cui presenza è soverchia e a tratti distubante. Su questo è chiaro che le inesperienze risultano più evidenti.
Bene i costumi di Roberta Serra, adattabili e capaci di modificare destinazione d’uso nel corso della rappresentazione. Ospitato all’interno della sala Minimax del Massimo di Cagliari, lo spettacolo ha avuto nelle repliche dal 29 novembre all’11 dicembre un buon riscontro di pubblico, ad incoraggiare l’opera prima e a spingere i giovani attori a continuare a provarci e a mantenere alta la
tensione e l’impegno. Il nostro augurio è quello di conservare la conoscenza degli strumenti didattici ma di tanto in tanto di dimenticarli, di lasciarli un attimo da parte per cercare la ragione del fare in uno stimolo che tenti, con l’audacia tipica degli artisti, di dire qualcosa di nuovo.
Un video de La Mandragola
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Wkky9ObDLCU&w=560&h=315]
Il video di Cabaret emotivo
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=WTT2XLh-pII&w=560&h=315]

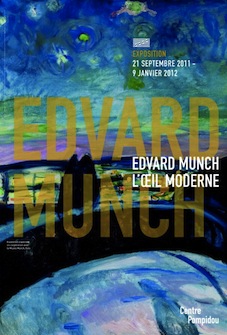 MARIA CRISTINA SERRA | Un’emozionante mostra al Centre Pompidou (“Edvard Munch, l’oeil moderne”, fino al 9 Gennaio 2012) pone l’accento sugli aspetti meno conosciuti dell’artista norvegese, solitamente identificato come un solitario, ripiegato sull’universo interiore, ma che invece viveva pienamente la realtà che lo circondava
MARIA CRISTINA SERRA | Un’emozionante mostra al Centre Pompidou (“Edvard Munch, l’oeil moderne”, fino al 9 Gennaio 2012) pone l’accento sugli aspetti meno conosciuti dell’artista norvegese, solitamente identificato come un solitario, ripiegato sull’universo interiore, ma che invece viveva pienamente la realtà che lo circondava
 BRUNA MONACO | È passato un anno da “Displace # 1 La rabbia rossa”. Era sempre il Romaeuropa Festival, sempre i Muta Imago, ma allora si trattava di uno studio, prima tappa di un progetto che si è concluso questo 25 novembre al Teatro Vascello, con la prima assoluta di “Displace”.
BRUNA MONACO | È passato un anno da “Displace # 1 La rabbia rossa”. Era sempre il Romaeuropa Festival, sempre i Muta Imago, ma allora si trattava di uno studio, prima tappa di un progetto che si è concluso questo 25 novembre al Teatro Vascello, con la prima assoluta di “Displace”. BRUNA MONACO | Le compagnie invitate a Roma per inaugurare la rassegna “Corpi Resistenti” all’interno della 26° edizione del Romaeuropa Festival appartengono a scene invisibili. Non solo perché lontane, ma perché operano in contesti in cui la libertà d’espressione spesso non è garantita: Iraq, Algeria, Tunisia, Egitto. Sono corpi che per esistere sulla scena devono resistere nella vita quelli di Selma e Sofiane Ouissi, Mahmoud Rabiey (in arte Vito), Muhanad Rasheed, Fares Fettane, i cui spettacoli si sono svolti e si svolgeranno ancora tra il Palladium e l’Eliseo, tra il 7 e il 27 novembre.
BRUNA MONACO | Le compagnie invitate a Roma per inaugurare la rassegna “Corpi Resistenti” all’interno della 26° edizione del Romaeuropa Festival appartengono a scene invisibili. Non solo perché lontane, ma perché operano in contesti in cui la libertà d’espressione spesso non è garantita: Iraq, Algeria, Tunisia, Egitto. Sono corpi che per esistere sulla scena devono resistere nella vita quelli di Selma e Sofiane Ouissi, Mahmoud Rabiey (in arte Vito), Muhanad Rasheed, Fares Fettane, i cui spettacoli si sono svolti e si svolgeranno ancora tra il Palladium e l’Eliseo, tra il 7 e il 27 novembre. BRUNA MONACO | Grandissimo regista, fondatore del Théâtre des Bouffes du Nord, a 86 anni Peter Brook realizza il suo sogno e nasce “Un flauto magico”, versione molto rivista della celeberrima opera di Mozart. È il Teatro Argentina ad ospitarlo fino al 27 novembre, all’interno del Romaeuropa Festival.
BRUNA MONACO | Grandissimo regista, fondatore del Théâtre des Bouffes du Nord, a 86 anni Peter Brook realizza il suo sogno e nasce “Un flauto magico”, versione molto rivista della celeberrima opera di Mozart. È il Teatro Argentina ad ospitarlo fino al 27 novembre, all’interno del Romaeuropa Festival.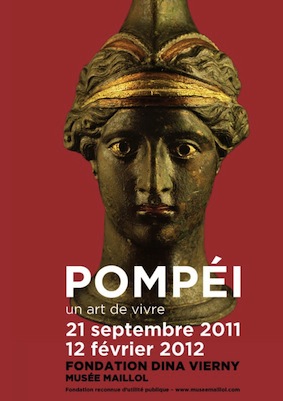 MARIA CRISTINA SERRA | Fra promesse mancate e pericoli di nuovi crolli, Pompei confida nel finanziamento europeo di 105 milioni di euro, mentre la sua “Art de vivre” brilla nel suo splendore alla mostra del Museo Maillol, in collaborazione con la Sovrintendenza per i Beni archeologici di Napoli e la Fondazione Dina Vierny (fino al 21 febbraio 2012)
MARIA CRISTINA SERRA | Fra promesse mancate e pericoli di nuovi crolli, Pompei confida nel finanziamento europeo di 105 milioni di euro, mentre la sua “Art de vivre” brilla nel suo splendore alla mostra del Museo Maillol, in collaborazione con la Sovrintendenza per i Beni archeologici di Napoli e la Fondazione Dina Vierny (fino al 21 febbraio 2012)