Iniziamo questa carrellata di opportunità “atipiche” da Bologna dove Fiorenza Menni/Teatrino Clandestino presentano “Hello Austria. Europa 2011” spettacolo che ha debuttato quest’estate con un allestimento open-air al Festival di Santarcangelo, presentato in una nuova versione nell’atelier della compagnia nelle giornate del 15, 16 e 17 dicembre nello spazio Sì di Via San Vitale, 67 a Bologna.
Costruito attorno al tema dell’identità europea, “Hello Austria. Europa 2011” è la voce di una donna che raccoglie su di sé più biografie, stralci di esperienze che trovano nel suo corpo e nella sua figura un punto di contatto. In questa nuova versione insieme a Fiorenza Menni è in scena la giovane attrice toscana Laura Dondoli, già apparsa sulle scene ne L’Avaro del Teatro delle Albe. Le due figure, in perenne dialogo con il violoncello di Francesco Guerri, plasmano una sorta di partitura musicale, un inno che compone di fronte agli occhi dello spettatore il ritratto di un’identità nomade, vivace, accesa dagli incontri intrapresi in diversi luoghi e momenti di un viaggio immaginario.
Il 16 dicembre inoltre sarà presentato anche Titolo Vero (Sì, ore 18.30) un progetto di Fiorenza Menni che prevede il coinvolgimento di attori esterni alla compagnia, e che in quest’occasione si accompagna alla presentazione della rivista Doppiozero di Marco Belpoliti (ore 19.00), mentre Sabato 17, al termine di Hello Austria, ci sarà il concerto di She Keeps Bees, band folk-rock in arrivo da New York (appuntamento alle ore 22.30 al Sì).
************************************
Da Bologna a Lecce per segnalare il 18 dicembre l’anteprima del nuovo spettacolo della compagnia salentina Astràgali, “Divenire animale”. Prima scrittura di una commedia per Fabio Tolledi da Uccelli di Aristofane e Attar, in scena al Teatro Paisiello a Lecce. Il 20 dicembre, poi, avverrà la costituzione e presentazione ufficiale, sempre al Teatro Paisiello, del nuovo Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’UNESCO, che avrà sede presso Astràgali e di cui Fabio Tolledi stesso sarà presidente. Sono due eventi importanti da diversi punti di vista per una compagnia la cui attività teatrale si fa atto politico e sociale nelle sue numerose campagne per la divulgazione delle arti sceniche nei paesi più difficili dell’area mediterranea e non solo.
“Divenire animale” è un lavoro di una certa complessità e quello che verrà presentato il 18 dicembre è un primo studio, che prelude ad un’anteprima più matura a inizio primavera, il 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro. Sulla scia di Lysistrata, recente successo della compagnia, presentato nell’estate 2010 a Lecce, Divenire animale si articola ancora una volta intorno a tre nessi inscindibili, potere-oscenità-riso, e, partendo da una inedita lettura di Uccelli (in relazione più segreta con Il verbo degli uccelli di Farid Ad-Din Attar), si interroga sulle categorie del politico, chiamando in causa il tema della sovranità, della crisi della forma-stato e della forma-città, dell’utopia, dell’animalità come segreto e approdo dell’umano. Si può “divenire animali” in una prospettiva non umana, scevra dall’assoggettamento e dal consumo? Questi in estrema sintesi sono alcuni dei punti di riflessione del lavoro che come sempre nelle intenzioni di Astràgali, vuole accogliere in sé spunti per l’analisi della società a cui l’individuo contribuisce a dare corpo.
******************************************
Segnaliamo da ultimo con piacere una proposta post-natalizia, in scena a Milano dal 27 al 31 dicembre presso lo Spazio Tertulliano. “Note per un collasso mentale” è una partitura per voci, corpi, chitarra, live electronics e altro liberamente ispirata all’opera del grande scrittore visionario J.G. Ballard, di cui è ricorso di recente l’anniversario dalla scomparsa. Regia, drammaturgia, luci, scena e costumi sono del giovane e audace Giuseppe Isgrò, regista appassionato della scena underground milanese, che si è concentrato da sempre su scrittori difficili come Ballard, Copi, A. Kristoff, per allestimenti dal tratto personale e lacerante.
Andrea Barettoni e Francesca Frigoli, accompagnati da Alessandra Novaga alla chitarra, danno vita ad una linea spezzata, ad un flusso interrotto e friabile ma in un certo qual modo continuabile ad libitum di immagini surreali, partorite dalla geniale mente di Ballard nel suo romanzo sperimentale “La mostra delle atrocità”- che nasce da diversi stimoli, incontri, e coincidenze. Si può definire Note il recital concitato di un testo attualissimo sui migliori e peggiori sentimenti della contemporaneità, un’ecografia al ventre gravido dell’immaginario attraverso la quale lo sguardo di Isgrò fa risuonare le capacità anticipatorie dello scrittore.
Caratteristiche di questo e altri spettacoli della compagnia sono una scena assolutamente spoglia ed essenziale, composta solo dall’hardware dello spettacolo in cui gli attori seguono traiettorie fisiche e gestuali significanti: non mere presenze narranti, dunque, ma voce, corpo, azione e relazione.
DISCLAIMER
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. Gli autori di PAC si riservano pertanto il diritto di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Gli autori del blog non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

 Devo dire di avere una personale attenzione e simpatia per le regie di Ugo Chiti e il lavoro che sempre con puntualità L’Arca Azzurra Teatro porta a compimento senza sbraitanti clamori. Eppure un po’ di spocchia potrebbero permettersela, alle soglie proprio dei trent’anni che ricorreranno nel 2013, da quel famoso laboratorio che Chiti condusse con gli allora ragazzi del gruppo. Di lì in avanti, lui ha continuato ad essere il punto di riferimento registico della compagnia, di cui ha firmato tutti gli spettacoli e loro il braccio armato di un modo di fare scena pulito, senza fronzoli, attento a quel voler far teatro in lingua toscana che era uno dei postulati di partenza, sfruttando appieno l’enorme comunicativa sonora e gestuale della lingua regionale, ma superando derive folclorico-vernacolari da casa del popolo.
Devo dire di avere una personale attenzione e simpatia per le regie di Ugo Chiti e il lavoro che sempre con puntualità L’Arca Azzurra Teatro porta a compimento senza sbraitanti clamori. Eppure un po’ di spocchia potrebbero permettersela, alle soglie proprio dei trent’anni che ricorreranno nel 2013, da quel famoso laboratorio che Chiti condusse con gli allora ragazzi del gruppo. Di lì in avanti, lui ha continuato ad essere il punto di riferimento registico della compagnia, di cui ha firmato tutti gli spettacoli e loro il braccio armato di un modo di fare scena pulito, senza fronzoli, attento a quel voler far teatro in lingua toscana che era uno dei postulati di partenza, sfruttando appieno l’enorme comunicativa sonora e gestuale della lingua regionale, ma superando derive folclorico-vernacolari da casa del popolo.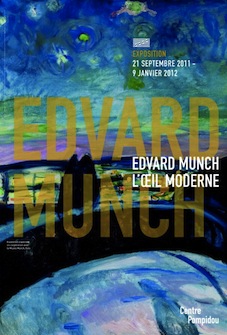 MARIA CRISTINA SERRA | Un’emozionante mostra al Centre Pompidou (“Edvard Munch, l’oeil moderne”, fino al 9 Gennaio 2012) pone l’accento sugli aspetti meno conosciuti dell’artista norvegese, solitamente identificato come un solitario, ripiegato sull’universo interiore, ma che invece viveva pienamente la realtà che lo circondava
MARIA CRISTINA SERRA | Un’emozionante mostra al Centre Pompidou (“Edvard Munch, l’oeil moderne”, fino al 9 Gennaio 2012) pone l’accento sugli aspetti meno conosciuti dell’artista norvegese, solitamente identificato come un solitario, ripiegato sull’universo interiore, ma che invece viveva pienamente la realtà che lo circondava
 BRUNA MONACO | È passato un anno da “Displace # 1 La rabbia rossa”. Era sempre il Romaeuropa Festival, sempre i Muta Imago, ma allora si trattava di uno studio, prima tappa di un progetto che si è concluso questo 25 novembre al Teatro Vascello, con la prima assoluta di “Displace”.
BRUNA MONACO | È passato un anno da “Displace # 1 La rabbia rossa”. Era sempre il Romaeuropa Festival, sempre i Muta Imago, ma allora si trattava di uno studio, prima tappa di un progetto che si è concluso questo 25 novembre al Teatro Vascello, con la prima assoluta di “Displace”. BRUNA MONACO | Le compagnie invitate a Roma per inaugurare la rassegna “Corpi Resistenti” all’interno della 26° edizione del Romaeuropa Festival appartengono a scene invisibili. Non solo perché lontane, ma perché operano in contesti in cui la libertà d’espressione spesso non è garantita: Iraq, Algeria, Tunisia, Egitto. Sono corpi che per esistere sulla scena devono resistere nella vita quelli di Selma e Sofiane Ouissi, Mahmoud Rabiey (in arte Vito), Muhanad Rasheed, Fares Fettane, i cui spettacoli si sono svolti e si svolgeranno ancora tra il Palladium e l’Eliseo, tra il 7 e il 27 novembre.
BRUNA MONACO | Le compagnie invitate a Roma per inaugurare la rassegna “Corpi Resistenti” all’interno della 26° edizione del Romaeuropa Festival appartengono a scene invisibili. Non solo perché lontane, ma perché operano in contesti in cui la libertà d’espressione spesso non è garantita: Iraq, Algeria, Tunisia, Egitto. Sono corpi che per esistere sulla scena devono resistere nella vita quelli di Selma e Sofiane Ouissi, Mahmoud Rabiey (in arte Vito), Muhanad Rasheed, Fares Fettane, i cui spettacoli si sono svolti e si svolgeranno ancora tra il Palladium e l’Eliseo, tra il 7 e il 27 novembre. BRUNA MONACO | Grandissimo regista, fondatore del Théâtre des Bouffes du Nord, a 86 anni Peter Brook realizza il suo sogno e nasce “Un flauto magico”, versione molto rivista della celeberrima opera di Mozart. È il Teatro Argentina ad ospitarlo fino al 27 novembre, all’interno del Romaeuropa Festival.
BRUNA MONACO | Grandissimo regista, fondatore del Théâtre des Bouffes du Nord, a 86 anni Peter Brook realizza il suo sogno e nasce “Un flauto magico”, versione molto rivista della celeberrima opera di Mozart. È il Teatro Argentina ad ospitarlo fino al 27 novembre, all’interno del Romaeuropa Festival.